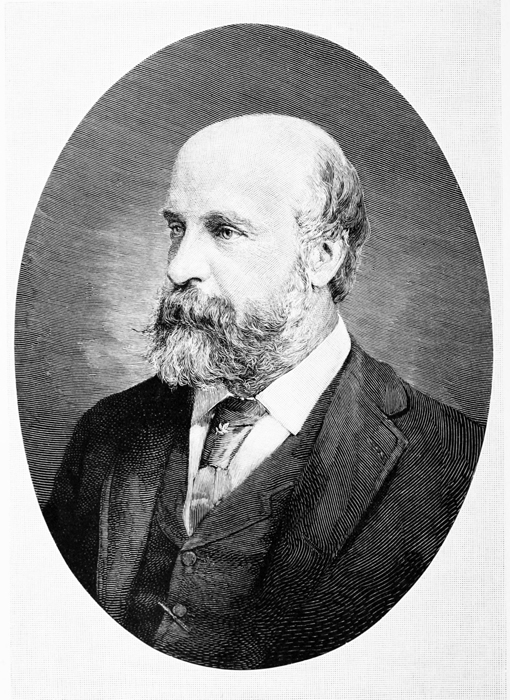Pagina on-Line dal 12/05/2012
_________________________
OPUSCOLO DELLA FILOSOFIA NATURALE DEI METALLI DI DENIS ZACHAIRE, GENTILUOMO DELLA GUIENNA.
Traduzione e note di Massimo Marra © – tutti i diritti riservati, riproduzione e diffusione vietata con qualsiasi mezzo e con qualsiasi fine.
___________________
PREFAZIONE (1).
Dal momento che tutti coloro che hanno scritto di questa divina scienza, giustamente ed a buon diritto denominata filosofia naturale, hanno espressamente vietato la sua divulgazione e profanazione, così, amico lettore, avendo letto e riletto diverse e continuate volte i libri dei filosofi naturali e pensato quotidianamente all’interpretazione delle contraddizioni, figure, comparazioni, equivoci ed enigmi diversi che appaiono in infinito numero nei loro libri, ho voluto nascondere e celare la loro risoluzione; a questa sono potuto arrivare dopo aver lungamente lavorato alle sofisticazioni e ricette maledette, o, per parlare più propriamente, inganni [A], da cui per molto tempo sono stato avviluppato ed imprigionato più di quanto non lo fosse nel suo labirinto lo stesso Dedalo.
Ma infine, attraverso la continua lettura di autori buoni e di provata scienza, come Geber nella sua Summa, sono arrivato a dire: ritornando in me stesso e considerando la vera via ed il modo di cui la natura fa uso sotto terra per la procreazione dei metalli, ho conosciuto la vera e perfetta materia che la natura stessa ci ha preparato per perfezionarli sopra la terra. Di ciò l’esperienza mi ha successivamente certificato, grazie al signore Dio che mi ha fatto tanti favori e grazie per mezzo del suo caro Figlio, il nostro Redentore Gesù Cristo, come dirò più ampiamente nella prima parte del presente Opuscolo in cui chiarirò il modo attraverso cui sono pervenuto alla conoscenza di questa opera divina. Nella seconda, invece, mostrerò di quali autori mi sono servito nel mio studio, citando le loro autorità in buon ordine e con veridico metodo, col fine di conoscere meglio le proprietà e le spiegazioni dei termini della scienza. Nella terza ed ultima parte esporrò la pratica in modo tale che essa rimarrà nascosta agli ignoranti e mostrata invece chiaramente ai veri figli della scienza, per i quali ho grandemente penato nell’intento di redigere il tutto nel miglior ordine possibile. Non volendo imitare in ciò diversi autori che hanno preceduti, i quali sono stati tanto invidiosi del pubblico bene ed amatori di quello particolare, che non hanno voluto esporre la materia che sotto diverse e mutevoli allegorie, senza mostrare, semplicemente, i loro libri: ne ho conosciuto, ai miei tempi, uno che aveva tanto cari e nascosti degli scritti che aveva recuperato da un gentiluomo veneziano, che lui stesso non osava che guardarli a metà, credendo evidentemente che la grande opera dovesse un giorno sortire da quelle pagine senza che lui si dovesse tormentare d’altro impegno che quello di conservare i suoi scritti in una cassa ben chiusa.
Ma tal tipo di persone devono sapere che quest’opera tanto divina non ci può esser donata da un caso fortuito, come dicono i filosofi quando rimproverano coloro che lavorano a credito, come fanno quasi tutti gli operatori odierni, dai quali non dubito che sarò aspramente ripreso ed accusato per aver pubblicato il mio Opuscolo; essi diranno che commetto una gran follia pubblicando così la mia opera, per di più in volgare, dato che non vi è scienza che oggi sia tanto odiata dal volgo quanto questa.
Ma, per risponder loro, voglio anzitutto che sappiano, se ancora non lo sanno, che questa divina filosofia non è affatto in potere dell’uomo, e che meno che mai può essere conosciuta attraverso i libri se il nostro buon Dio non l’ispira nei nostri cuori attraverso il suo Spirito Santo o per mezzo di qualche uomo vivente, come proverò ampiamente nella seconda parte di questo mio Opuscolo. Non è certo sufficiente leggerla in questo trattatello. E quanto all’uso della lingua volgare, che essi sappiano che in ciò nulla ho fatto di nuovo, avendo piuttosto imitato autori antichi i quali tutto hanno scritto nella loro lingua madre, come Hamec, filosofo ebreo che scrisse in lingua ebraica, Thébit e Haly, filosofi caldei, nel loro linguaggio caldaico, Omero, Teofrasto, Democrito e tanti altri filosofi greci nella loro lingua greca, Abobaly, Geber, Avicenna, filosofi arabi, nella loro lingua araba, e Morieno, Raimondo Lullo e diversi altri filosofi latini in lingua latina, affinché i loro successori sapessero che questa divina scienza era stata rivelata alle genti della loro nazione. Se dunque ho imitato tutti questi autori e diversi altri nei loro scritti, non c’è da meravigliarsi che io abbia seguito il loro esempio nel modo di scrivere, affinché anche quelli che sono oggi viventi e che ci seguiranno in futuro sappiano che il nostro Dio benedetto ha voluto, per sua santa e divina misericordia, gratificare di tal conoscenza anche il nostro buon paese di Guienna, come d’altra parte ha fatto con le altre nazioni.
E quanto a ciò che essi dicono, che la nostra scienza è odiata dal volgo, ciò non risponde al vero, perché la verità, appena è conosciuta, viene sempre amata; sono piuttosto gli inganni e le false sofisticazioni ad essere odiate, come più ampiamente chiarirò nella prima parte.
Ma, essi diranno, dal momento che io non spiego chiaramente tutte le cose richieste per la composizione della nostra opera divina, in modo che tutti coloro che leggano il mio Opuscolo possano sicuramente lavorare, quale profitto si potrà mai trarre leggendo questa mia opera? Io dico un grande e duplice profitto. Per prima cosa, chi saprebbe descrivere le grandi ricchezze che si sprecano oggigiorno in Francia nel seguire tutte queste maledette sofisticazioni? Piaccia a Dio che esse spariscano per sempre e che, grazie alla lettura del mio Opuscolo, si metta fine a tanti folli sprechi. Non sarebbe ciò conseguire un gran profitto? Senza contare il secondo profitto che i buoni e fedeli lettori potranno riportare, dirigendo i loro studi secondo il metodo autentico che io ho dato nella seconda parte. E se Dio farà loro la grazia che possano conseguire quella risoluzione che descriverò in seguito, la terza parte non gli sarà inutile per avere ulteriore accesso a questa divina pratica. Dico divina perché essa è tale che l’intendimento umano, fosse anche quello dei più grandi filosofi, non può comprenderla da sé, come chiarisce Geber quando rimprovera coloro che vorrebbero lavorare considerando unicamente le cause naturali e le operazioni della natura: in ciò – egli dice – falliscono gli operatori odierni, perché essi pensano di seguire la natura, che la nostra arte non può però eguagliare in tutto.
Cessino dunque di parlare tali calunniatori, ai quali voglio dire di non darsi pena di leggere il mio Opuscolo, poiché non è per loro che lho composto, ma per i figli benevoli, docili ed amorevoli della nostra scienza: costoro io prego umilissimamente che, prima di intraprendere i lavori, acquisiscano comprensione di tutte le operazioni necessarie alla composizione della nostra opera divina, adattandole a tutte le sentenze, contraddizioni, enigmi, equivoci che si trovano nei libri dei filosofi, al punto da non percepire in essi più alcuna contraddizione o diversità di vedute. Perché è questo il vero metodo per conoscere la verità, specie in questa divina filosofia, come al meglio ha scritto Razi, dicendo: colui che sarà pigro nella lettura dei nostri libri non sarà mai pronto a preparare le materie. Perché ogni libro chiarisce l’altro, e ciò che manca nell’uno è aggiunto nell’altro. Perciò, per lo stesso volere divino, non bisogna mai attendersi di trovare tutto il procedimento della nostra divina opera tutto descritto e chiarito nel giusto ordine, il che è stato ben scritto da Aristotele al re Alessandro in risposta alla sua preghiera: Non è lecito – egli dice – domandare cosa che non sia permesso concedere. Come puoi dunque pensare che io comunichi per iscritto quel che, se fosse scritto, i cuori degli uomini non potrebbero comunque comprendere? Con ciò egli dava a intendere, per mezzo del rifiuto che egli opponeva al re, suo padrone, che gli era vietato per ordine divino il pubblicare la nostra scienza in termini che fossero comprensibili per tutti.
Perciò oggi scongiuro tutti quelli che, per mezzo del mio presente Opuscolo, perverranno alla vera conoscenza di questa opera divina, di usarla per nutrire i poveri, liberare gli oppressi e sollevare i crucciati, per amore del nostro Dio; è questi che li ha infatti beneficiati di tale grandissimo bene, del quale ancora una volta li prego di riconoscere la grandezza e la provenienza divina, e di far uso secondo i santi comandamenti. Facendo ciò, Dio farà che essi prosperino nei loro affari, così come, nel caso contrario, egli tutto potrà volgere a loro detrimento e confusione.
Ti supplico dunque, amico fedele, affinché, leggendo i nostri libri, tu abbia sempre in mente il buon Dio, poiché ogni bene discende da lui e, senza il suo aiuto, nulla può aversi di perfetto in questo basso mondo, e tanto meno si può giungere alla conoscenza di questo grande ed ammirevole bene, se il suo Spirito Santo non ci è dato per guida. E ciò avverrà davvero se non sarai guidato dall’avarizia e sarai vero zelatore di Gesù Cristo, al quale sia lode gloriosa per tutti i secoli dei secoli. Così sia.
I – COME L’AUTORE È PERVENUTO ALLA CONOSCENZA DI QUEST’OPERA DIVINA.
Ermete, giustamente chiamato Trismegisto, parola che è comunemente interpretata col significato di tre volte grande, primo autore e profeta dei filosofi naturali, dopo aver visto per esperienza la certezza e verità di questa divina filosofia, ha ben lasciato scritto che, non fosse stato per il timore che egli aveva del giudizio universale che il dio sovrano deve emettere per ogni creatura ragionevole negli ultimi giorni della fine del mondo, egli giammai avrebbe lasciato per iscritto nulla di questa divina scienza, tanto egli la stimava, a giusto titolo, grande ed ammirevole. Di questa opinione sono stati tutti gli autori principali che l’hanno seguito. Per questo motivo essi hanno tutti scritto i loro libri in modo tale, come dice Geber nella sua Summa, da perseguire sempre due fini, ovvero il far fallire gli ignoranti e chiarire, sotto il velo della varietà delle opinioni, il loro intento principale a figli della scienza. A questi conviene errare al principio, affinché, essi dicono, avendo acquisito la scienza con gran pena e lavoro di corpo e di mente, la tengano poi più cara e segreta. E invero la cosa migliore è non diffonderla affatto, poiché ci vuole una pena indicibile per acquisirla, senza contare i costi e le spese da affrontare, che sono grandi, prima di pervenire alla perfetta conoscenza di questa opera divina. Parlo qui di quelli che non hanno altro maestro che i libri, e che attendono l’ispirazione dal nostro buon Dio, come io ho fatto per lo spazio di dieci anni.
In primo luogo, per raccontare il vero susseguirsi degli eventi ed il modo in cui io sono pervenuto alla conoscenza, avendo all’incirca venti anni, dopo esser stato istruito nella nostra casa per sollecitudine e diligenza dei miei genitori ai principi della grammatica, fui inviato a Bordeaux per studiare le arti al collegio, perché ivi insegnavano ordinariamente dei professori assai sapienti; qui io rimasi quasi sempre a studiare, per lo spazio di tre anni, la filosofia, nella quale conseguii un tal profitto, per grazia di Dio e sollecitudine di un maestro privato che i miei genitori mi avevano dato, che sembrò bene, a tutti i miei amici e parenti (dal momento che, in quel frattempo, avevo perduto madre e padre, che mi avevano così lasciato solo al mondo) che io andassi a Tolosa sotto la direzione del detto mio maestro personale per studiare legge. Tuttavia non partii da Bordeaux senza aver conosciuto altri studenti che avevano diversi libri di ricette raccolte da diversi autori, le quali mi furono familiari, perché il mio maestro le praticava. Non fui così pigro da lasciare un sol foglio da ricopiare di tutti i libri che potevo recuperare, di modo che, prima di partire per Tolosa, io ne avevo copiato un tomo grande e grosso dello spessore di tre dita, in cui avevo scritto diverse proiezioni, un peso su dieci, un altro su venti, su trenta, con molte mezze ricette per il rosso, l’una a diciotto carati, l’altra a venti, un’altra ancora per l’oro da scudi, da ducati, altre infine per farne di colore migliore che mai. Le une dovevano sostenere la fusione, le altre la pietra di paragone, le altre ogni giudizio ed altre infinite prove. Ugualmente per il bianco, di cui uno doveva venire da dieci denari, l’altro da undici, l’altro ancora da testone, l’uno al bianco di fuoco, l’altro al tocco, di modo che mi sembrava che, se avessi avuto una volta la possibilità di mettere in pratica la minore di queste ricette, sarei diventato l’uomo più felice del mondo. E, principalmente, delle tinture che avevo recuperato, le une erano, nel titolo, attribuite alla regina di Navarra, le altre al fu cardinale di Lorena, le altre ancora al cardinale di Tournon ed ad altri infiniti nomi, affinché, come capii in seguito, vi si prestasse maggior fede, cosa che io del resto facevo allora [B]. Non appena fui a Tolosa, dopo aver tutto confessato al mio maestro, mi misi a costruire dei piccoli forni. Poi dai piccoli arrivai i grandi, in modo che ne ebbi una camera tutta circondata; gli uni erano per distillare, altri per sublimare, calcinare, dissolvere nel bagno Maria, altri ancora per fondere. In questo modo, per i miei inizi, spesi in un anno più di duecento scudi, che ci erano stati inviati per mantenerci per due anni di studi, e che furono invece spesi tanto per costruire forni che per comperare carbone, innumerevoli ed infinite droghe, diversi vasi di vetro – che comperai per sei scudi l’uno – senza contare le due once d’oro che si perdettero nel praticare una delle ricette e i due o tre marchi d’argento che si perdettero nel praticarne un’altra. Quando talvolta se ne recuperava un poco, era talmente acido ed annerito a causa del gran numero di miscugli che le dette ricette prescrivevano, che era pressoché del tutto inutilizzabile. In tal modo, entro la fine dell’anno, i miei duecento scudi erano andati in fumo ed il mio maestro morì d’una febbre continua che lo aveva preso d’estate a forza di soffiare e di assorbire calore, dal momento che egli, per la gran voglia di concludere qualcosa di buono, non si partiva mai dalla camera, in cui faceva un caldo non minore di quello che doveva fare nell’arsenale di Venezia nella fucina delle artiglierie. La morte del mio maestro mi fu assai dannosa, perché i miei parenti si rifiutarono di mandarmi più danaro di quanto non fosse strettamente necessario per mantenermi agli studi, mentre io non desideravo altra cosa che avere i mezzi per continuare.
Ciò mi costrinse a tornare a casa mia per liberarmi dalla tutela dei miei curatori, al fine di entrare in possesso di tutti i miei beni paterni, dai quali ebbi per tre anni una rendita di quattrocento scudi, che utilizzai per realizzare in particolare una ricetta, tra le altre, che un italiano, che tenni con me per portare a termine la sua stessa ricetta, mi aveva lasciato a Tolosa, assicurandomi di aver visto realizzarsi l’esperienza. Per metterla in pratica, dovetti comperare due once d’oro ed un marco d’argento, i quali, una volta fusi insieme, facemmo dissolvere con acqua forte, e poi calcinammo per evaporazione, provando a dissolverli con diverse altre acque e distillazioni, tante volte che, in questo modo, passarono due mesi prima che la polvere fosse pronta per farne proiezione. La usammo come indicava la ricetta, ma tutto fu vano, perché il profitto che ne ricevetti fu solo una diminuzione del peso, poiché di tutto l’oro e l’argento che avevo usato non recuperai che un mezzo marco, senza contare le altre spese che non furono piccole. Così i miei quattrocento marchi divennero duecentotrenta, dei quali venti andarono al mio italiano per andare a trovare l’autore di questa ricetta, che diceva essere a Milano, al fine di indirizzarci. In tal modo rimasi a Tolosa tutto l’inverno attendendo il suo ritorno, ma, se avessi voluto continuare l’attesa, sarei ancora lì, perché l’italiano non si vide più.
In seguito, l’estate arrivò accompagnata da una grande pestilenza che mi fece abbandonare Tolosa. E per non lasciare i compagni che avevo conosciuto, me ne andai a Cahor dove rimasi sei mesi, durante i quali non tralasciai di continuare la ma impresa accompagnandomi con un vecchio e buon uomo che veniva comunemente chiamato – Il filosofo – al quale mostrai i miei appunti. Gli domandai consiglio per sapere quale ricetta gli sembrava essere la più promettente, a lui che tanti semplici aveva maneggiato durante la sua vita, ed egli me ne indicò dieci o dodici che, a suo avviso erano migliori. Non appena fui tornato a Tolosa, per la festa di Ognissanti, dopo che il pericolo della pestilenza era cessato, cominciai subito a metterle in pratica, ed in tale impegno passai tutto l’inverno, riportandone un profitto non dissimile da quello dei precedenti tentativi. In questo modo, dopo la festa di San Giovanni, io trovai i miei quattrocento scudi diminuiti a centosettanta, ma non per questo rinunciai perseguire il mio obiettivo.
Anzi, per meglio continuare, mi accostai ad un abate che viveva vicino Tolosa, che si diceva avere la copia di una ricetta per fare la nostra grande opera, che un suo amico del seguito del cardinale d’Armagnac gli aveva inviato da Roma, e che egli custodiva attentamente, poiché doveva valere duecento scudi: di tal somma io fornii cento scudi e lui l’altra metà. Cominciammo così a costruire nuovi forni, tutti di fogge diverse, per lavorare, e, poiché ci occorreva un’acquavite forte sovrana per dissolvere un marco d’oro, comprammo, per produrla, un fusto di vino di Gaillac, dal quale, per mezzo di un pellicano assai grande, traemmo la nostra acquavite. In questo modo, nel giro di un mese, noi avemmo dell’acqua passata e ripassata diverse, volte, in quantità maggiore rispetto a quella che ci occorreva. Poi, bisognava avere diversi vasi di vetro per purificarla ed assottigliarla ulteriormente; ne mettemmo in seguito quattro marchi dentro due grandi storte di vetro assai spesse, in cui c’era il marco d’oro che avevamo precedentemente calcinato per un mese con fuoco di fiamma molto forte, e ponemmo queste due storte l’una nell’altra, ben lutate; le ponemmo su due forni grandi tondi, e spendemmo trenta scudi di carbone tutti d’un colpo per alimentare il fuoco continuamente per un anno intero. Durante questo periodo, ogni giorno provavamo qualche piccola ricetta, dalla quale traevamo il medesimo profitto della nostra grande opera. Quanto a questa, saremmo ancora lì ad attendere, se avessimo voluto aspettare che essa si fosse congelata nel mezzo del fondo delle storte, come prometteva la ricetta; e ciò non senza causa, poiché ogni congelazione è sempre preceduta da dissoluzione, e noi non lavoravamo sulla materia dovuta, dal momento che, come ci mostra l’esperienza, non è l’acqua che dissolve il nostro oro. Trovammo così nelle nostre storte tutto l’oro in polvere esattamente come ce lo avevamo messo, eccetto per il fatto che esso era un po’ più sciolto; di quest’oro facemmo proiezione su dell’argento vivo riscaldato, ma invano.
Se noi ne fossimo desolati, ve lo lascio immaginare; soprattutto l’abate che, da ottimo custode di segreti, aveva già comunicato ai suoi monaci che non restava che far fondere una bella fontana di piombo che essi avevano nel loro chiostro, per convertirla in oro non appena il nostro lavoro fosse stato portato a termine. La fontana egli la fece fondere un’altra volta, ma per aver mezzo di far lavorare invano qualche tedesco che passava alla sua abbazia, mentre io ero a Parigi. Comunque sia, egli pure non cessava di voler continuare l’impresa, e mi consigliò quindi di mettermi d’impegno a recuperare tre o quattrocento scudi, ed egli me ne avrebbe forniti altrettanti, per andarmene a Parigi, la città oggigiorno più frequentata dai diversi operatori di questa scienza che vi sia in Europa. Lì avrei lavorato con ogni sorta di gente, e, se avessi trovato qualcosa di buono, l’avremmo fraternamente condiviso. Io investii di nuovo le rendite di tutti i miei beni e me ne andai così a Parigi con ottocento scudi in borsa, deliberato a non partire di lì se non quando avessi finito il denaro o non avessi trovato qualcosa di buono. Ma ciò non fu senza prima incorrere nella mala grazia di tutti i miei parenti ed amici, che non cercavano altro che di fami consigliere della nostra città, poiché avevano l’opinione che io fossi un gran leguleio. Tuttavia, nonostante le loro preghiere (dopo avergli fatto credere che me ne andavo a Corte per acquisire un alto incarico), partii il giorno dopo Natale, ed arrivai a Parigi tre giorni dopo l’Epifania; vi rimasi per un mese, pressoché sconosciuto a tutti, ma, dopo che ebbi cominciato a frequentare artigiani come orefici, costruttori di fornaci ed altri, ne accostai talmente tanti che non fu passato un altro mese che ebbi fatta conoscenza di più di cento operatori. Gli uni lavoravano alle tinture dei metalli per proiezione, gli altri per cementazione, alcuni per dissoluzione, altri per congiunzione dell’essenza (come dicevano) dello smeriglio, altri ancora per lunghe decozioni, alcuni lavoravano all’estrazione dei mercuri dei metalli, altri infine alla loro fissazione. In questo modo non passava giorno (domenica e feste comprese) che noi non ci riunissimo a casa di qualcuno, e spesso alla mia, o a Notre-Dame-la-Grande che è la chiesa più frequentata di Parigi, per parlare dei rispettivi lavori svolti nei giorni precedenti. Gli uni dicevano: Se avessimo il modo di ricominciare faremmo certamente qualcosa di buono. Gli altri, invece: se il nostro vaso avesse tenuto, saremmo riusciti. Altri ancora: Se avessimo avuto il nostro vaso di rame ben rotondo e sigillato, avremmo fissato il mercurio con la luna. Non ve ne era uno che avesse combinato qualcosa di buono, e che non avesse la sua propria scusa. Per questo, non mi affrettavo certo a presentargli denaro, ben conoscendo le grandi spese che in precedenza avevo dovuto affrontare a credito, fidandomi delle altrui assicurazioni.
Tuttavia, durante l’estate, arrivò un greco che veniva stimato come gran sapiente, il quale si indirizzò ad un tesoriere che io conoscevo, promettendogli lavori assai belli. Tale conoscenza fece si che io cominciassi a finanziare con lui i lavori per fissare, come lui diceva, il mercurio del cinabro. E poiché il greco aveva bisogno di limatura fine d’argento, ne acquistammo tre marchi e li facemmo limare; egli ne fece dei piccoli chiodi con un impasto artificiale, e li mescolò con cinabro polverizzato, facendoli cuocere per un certo tempo in un vaso di terra ben coperto. Quando erano ben secchi, egli li faceva fondere o li passava per coppella, ed in questo modo noi trovammo tre marchi e poco più di argento fino, che egli diceva essere uscito dal cinabro, mentre ciò che noi avevamo messo d’argento fino se ne era volato in fumo. Se ci fosse profitto lo sa Iddio, ed io pure, che spendevo di tasca mia più di trenta scudi. Tuttavia, egli assicurava sempre che c’era da guadagnarci. In tal modo, prima del Natale seguente, la cosa era divenuta tanto conosciuta a Parigi che non vi era figlio di buona madre che si occupasse della scienza (vale a dire nelle sofisticazioni) che non avesse sentito parlare dei chiodi di cinabro, così come tempo dopo si parlò dei pomi di rame per fissarvi all’interno il mercurio con la luna.
Mentre passava il tempo in queste leggerezze, arrivò un gentiluomo straniero, grandissimo esperto in sofisticazioni, esperienza di cui ordinariamente faceva profitto vendendo i suoi servizi agli orefici, con il quale feci conoscenza il prima che mi fosse possibile; naturalmente, non senza spendere, dal momento che non volevo che egli mi considerasse un poveraccio. Prima che volesse rivelarmi alcunché, rimasi con lui per circa un anno; infine, mi mostrò il suo segreto che egli stimava assai grande, benché, in realtà, non fosse nulla di perfetto.
Ciò nonostante avvertii di tutto il mio abate, e gli inviai anche la copia della ricetta di questo gentiluomo. Egli mi rispose che non stimava uno spreco di denaro che io rimanessi ancora un altro anno a Parigi, visto che avevo trovato un tal bel principio che egli consierava di grande importanza, contro la mia opinione; io, infatti, avevo sempre ritenuto di non usare mai materia che non rimanesse tale quale appariva al principio, avendo già fin troppo bene imparato che non bisognava faticar tanto per essere malvagi ed arricchirsi a spese altrui. Perciò continuando sempre la mia ricerca, rimasi un altro anno, frequentando ora gli uni ora gli altri tra quelli di cui si aveva opinione che avessero qualcosa di interessante: coi due anni che vi avevo già trascorso, ero rimasto a Parigi per tre anni.
Avevo speso la maggior parte del denaro, quando ricevetti delle nuove dal mio abate che mi chiedeva di andarlo a trovare immantinente, non appena ricevuta la lettera. Poiché non volevo deluderlo in nulla, dal momento che eravamo legati da giuramento, lo feci subito. Quando arrivai, trovai presso di lui una lettera che il re di Navarra (che era grandemente curioso di tutte le cose di buona scienza) gli aveva scritto. Egli avrebbe fatto in modo che, se mai ci si fosse deliberati a lavorare per lui, ed io fossi andato a trovarlo a Pau in Béarn per insegnargli il segreto che avevo appreso dal mio gentiluomo, e gli altri di cui gli era stato riferito io ero a conoscenza, egli mi avrebbe trattato assai bene ricompensandomi di tre o quattromila sudi. Questa parola dei quattromila scudi solleticava talmente le orecchie dell’abate, che quasi credeva averli già in borsa, che egli senza cessa mi esortava a partire per Pau; vi arrivai nel mese di maggio e vi rimasi senza lavorare per circa sei settimane, poiché bisognava recuperare i vari semplici. Ma quando fui pronto ebbi esattamente la ricompensa che mi aspettavo, poiché, ancorché il re avesse buona volontà di farmi del bene, essendo circondato dai più grandi della corte, ed anche da coloro che erano stati causa della mia venuta, mi rispedì indietro con grandi ringraziamenti e con la promessa che l’avrei avvisato se vi era nulla nelle sue terre che fosse in suo potere donarmi, come beni confiscati o altre cose simili, ed egli volentieri me le avrebbe donate. Questa risposta mi irritò talmente che, senza prestar fede alle sue belle promesse, me ne ritorna dall’abate.
Ma, poiché avevo udito parlare di un dotto religioso che era stimato (ed a buon diritto) sapiente nella filosofia naturale, sulla strada del ritorno volli andare a conoscerlo; egli mi distolse con forza dalla via delle sofisticazioni, e dopo aver saputo che avevo studiato e mi ero addottorato in filosofia a Bordeaux, egli mi disse con molto zelo che era da rimpiangere grandemente che non avessi recuperato tanti buoni libri dei filosofi antichi che ordinariamente si possono reperire, e che avessi invece perduto tanto tempo e tanto denaro a credito in delle maledette sofisticazioni.
Gli parlai dei lavori che avevo intentato, ed egli mi seppe prontamente dire di cosa si trattava, e che tali risultati non avrebbero potuto sostenere molte prove. Egli mi distolse talmente da ogni sofisticazione, spingendomi ad occuparmi invece della lettura dei libri degli antichi filosofi al fine di conoscere la loro vera materia (nella quale, sembrava, risiedeva tutta la perfezione della scienza), che io tosto me ne andai dal mio abate per rendergli conto degli ottocento scudi che avevamo investito insieme e dargli la metà della ricompensa che avevo avuta dal re di Navarra. Arrivato da lui, gli raccontai tutto, ed egli ne fu grandemente desolato, ed ancor più lo fu del fatto che io non volessi più continuare l’impresa incominciata insieme, poiché egli riteneva io fossi un buon operatore. Tuttavia le sue preghiere non mi distolsero dal seguire il consiglio del buon dottore, date le buone ed evidenti ragioni che questi aveva addotte nel nostro colloquio. Avendo reso conto al mio abate di tutte le spese che avevo sostenute, restavano novanta scudi a ciascuno e, l’indomani, partimmo. Me ne torna a casa mia con la decisione di andarmene a Parigi e, lì arrivato, di non partirmene senza aver tratto, dalla lettura dei diversi libri dei filosofi naturali, qualche conclusione utile al lavoro della nostra grande opera, dopo aver dato il congedo ad ogni sofisticazione.
Dopo aver anzitutto recuperato il denaro dai miei affittuari, me ne andai a Parigi, dove arrivai all’indomani di Ognissanti dell’anno millecinquecentoquarantasei. Comprai libri di filosofia per dieci scudi, tanto di autori antichi che moderni, in parte stampati ed in parte manoscritti, come la Turba dei Filosofi, il buon Trevisano, il Lamento della natura ed altri diversi trattati che non erano mai stati stampati. Avevo locato una piccola camera nel sobborgo di S. Marceau, e rimasi lì per un anno con un ragazzino che mi serviva, senza frequentare nessuno, studiando giorno e notte questi autori, di modo che nel volgere di un mese io ero giunto ad una conclusione, indi a un’altra, che poi approfondivo per infine cambiare quasi del tutto, nell’attesa che ne stabilissi definitivamente una in cui non vi fosse né diversità né contraddizione con le sentenze dei libri dei filosofi. Tuttavia io passai tutto l’anno ed una parte del successivo senza poter concludere alcunché nel mio studio.
Intanto, in questa perplessità, mi misi a frequentare nuovamente coloro che sapevo lavoravano a questa opera divina, dal momento che non frequentavo più tutti gli altri operatori conosciuti in precedenza che lavoravano a tutte quelle maledette sofisticazioni. Ma, se uscivo dal mio studio con l’animo pieno di stizza, questa aumentava quando mi mettevo a considerare le diverse e variabili modalità con cui gli altri lavoravano. Infatti, se uno lavorava sul solo oro, l’altro procedeva con oro e mercurio insieme, un altro vi mescolava del piombo, che egli definiva sonante perché era stato sublimato con argento vivo. Un altro convertiva alcuni metalli in argento vivo per mezzo di diversi semplici, per sublimazione, un altro lavorava con atramento nero artificiale che egli diceva essere la vera materia della quale Raimondo Lullo faceva uso per la composizione di questa grande opera. Se uno lavorava in un solo alambicco, l’altro lavorava in diversi altri vasi di vetro, un altro di bronzo, l’altro di rame, l’altro di piombo, un altro di argento e qualcuno in vasi d’oro. Poi uno faceva la sua decozione a fuoco di grossi carboni, l’altro a fuoco di legno, l’altro di sterpi, l’altro al calore del sole ed altri a bagno-maria.
In questo modo la varietà delle loro operazioni, con le contraddizioni che vedevo nei libri, mi avevano pressoché gettato nella disperazione, quando, ispirato da Dio e dallo Spirito Santo, cominciai a rileggere con gran diligenza le opere di Raimondo Lullo, e principalmente il suo Testamento ed il Codicillo, i quali io confrontai così profondamente con una Epistola che egli scrisse ai suoi tempi a re Roberto e con un altro manoscritto di questo dottore che avevo reperito, che ne trassi una conclusione del tutto contraria a tutte le operazioni che avevo visto in precedenza, ma tale che io non leggevo più nulla in tutti i libri che non si adattasse benissimo alla mia opinione; vi si adattava perfino la conclusione che Arnaldo da Villanova, maestro di Raimondo Lullo in questa scienza, aveva scritto alla fine del suo Grande Rosario. Rimasi all’incirca un anno dopo, senza fare altra cosa che leggere e ripensare alle mie conclusioni giorno e notte, nell’attesa che scadesse il termine del fitto delle mie proprietà, con l’intento di andarmene a casa mia a lavorare; vi giunsi al tempo di Quaresima, deciso a mettere in pratica le mie conclusioni. Durante la Quaresima feci provvista di tutto ciò che mi occorreva, e costruii un forno per lavorare, in modo da poter cominciare il giorno dopo Pasqua.
Ciò, tuttavia, non avvenne senza diversi impedimenti (e di questi taccio i principali) provocati dai miei più prossimi vicini, parenti ed amici. L’uno mi diceva: che cosa vuoi fare? Non hai speso abbastanza in tali follie? L’altro mi assicurava che se avessi continuato a comprare tanto carbone si sarebbe sospettato che io falsificassi moneta, come egli aveva già in effetti udito dire. Poi veniva un altro, che diceva che tutti, anche i più grandi della nostra città, trovavano assai strano che io non professassi la toga, visto che ero addottorato in legge, al fine di pervenire a qualche onorevole ufficio nella città. Gli altri che mi erano più vicini mi redarguivano in continuazione, chiedendomi perché io non mettessi fine a queste folli spese, che sarebbe stato meglio per me risparmiare danaro per pagare i miei creditori e per acquistare qualche incarico, minacciandomi inoltre che essi mi avrebbero fatto arrivare in casa gli uomini della giustizia per distruggere tutto. Anzitutto dicevano essi, se nulla volete fare per amor nostro, abbiate almeno riguardo per voi stesso. Considerate che, pur avendo un’età di circa trenta anni, sembrate averne cinquanta, tanto sembra ingrigire la vostra barba, che vi fa apparire tanto invecchiato per le pene che avete sopportato nel perseguire le vostre giovanili follie. E con ciò essi mi importunavano ordinariamente con mille altre rampogne.
Vi lascio immaginare quanto queste frasi mi fossero fastidiose, soprattutto nella misura in cui io vedevo la mia opera condursi di bene in meglio; ero sempre intento alla mia opera, nonostante tali contrarietà ed impedimenti che sopravvenivano senza cessa, e principalmente il pericolo della peste che, durante l’estate, fu così grande, da bloccare ogni traffico e mercato. In questo modo non passava giorno che non sorvegliassi con grandissima diligenza l’apparizione dei tre colori che i filosofi hanno scritto dover apparire prima della perfezione della nostra opera divina. Li vidi, grazie al signore Iddio, l’uno dopo l’altro, in modo che, proprio il giorno della Pasqua seguente, ne feci vera e perfetta esperienza su dell’argento vivo riscaldato in crogiolo, che si convertì in oro fino davanti ai miei stessi occhi in meno di un’ora per mezzo di un po’ di questa divina polvere.
Quanto ne fossi contento, lo sa Iddio. Ma non per questo ne meno vanto.
Dopo aver reso grazie al nostro buon Dio, che tante grazie e favori mi aveva elargito per mezzo di suo Figlio, il nostro Redentore Gesù Cristo, e dopo averlo pregato affinché mi illuminasse attraverso il suo Spirito Santo per poter usare di questa grazia a suo onore e lode, l’indomani me ne andai a trovare l’abate nella sua abbazia, per mantenere la promessa che mi legava a lui; seppi però che era morto sei mesi prima, e di ciò fui grandemente addolorato. Allo stesso modo era morto anche il buon dottore, come seppi nel passare vicino al suo convento. Me ne andai perciò in un certo luogo per aspettarvi un mio amico e parente prossimo, con cui avevo preso appuntamento alla mia partenza, che avevo lasciato a casa mia con incarico ed espressa procura di vendere tutti i miei beni paterni, e con questi pagare i miei creditori e distribuire segretamente il resto a coloro che ne avevano bisogno, affinché i miei parenti ed altri ancora godessero di qualche frutto del gran bene che Iddio mi aveva donato senza che nessuno di loro se ne accorgesse. Al contrario, essi, come mi raccontò il mio amico, pensavano che io fossi alla disperazione e, avendo vergogna delle spese folli che avevo fatto, vendessi tutto per ritirarmi altrove. Il mio amico mi raggiunse il primo giorno del mese di luglio, ed andammo a Losanna, avendo deciso di viaggiare e passare il resto dei miei giorni in una certa più rinomata città tedesca con un piccolissimo seguito, per non essere riconosciuto neanche da coloro che leggeranno, nello spazio della mia vita, questo mio libro nel nostro paese di Francia. Ho voluto donare al mio paese questo scritto, non tanto per confessarmi protagonista di tante folli spese, che ordinariamente, del resto, si fanno quando si persegue questa scienza che tutti considerano sofistica, poiché solo in pochi lavorano alla vera e divina perfezione; quanto piuttosto per distogliere e rimettere sulla vera via il maggior numero possibile di cercatori.
Perciò a conclusione di questa prima parte, supplico umilissimamente tutti quelli che leggeranno il presente Opuscolo di ricordarsi ciò che il buon poeta ci ha lasciato per iscritto, e cioè: fortunati coloro si son fatti saggi a spese e pericolo altrui. Ciò affinché, nel leggere come sono giunto alla perfezione di questa divina opera, apprendano a non più dipendere da vani e sofistici inganni [C], e non si illudano di pervenire al fine per mezzo di quelle. Poiché, come ho già avvertito nella mia epistola preliminare, non è per un caso fortuito che vi si perviene, ma per lungo e continuo studio dei buoni autori, quando è buon piacere del nostro Dio assisterci attraverso il suo Spirito Santo, dal momento che assai difficilmente coloro che hanno il segreto lo rendono pubblico. Supplico umilissimamente Iddio che gli piaccia di donarmi la grazia di farne buon uso, e di assistere tutti i buoni fedeli che leggeranno il mio Opuscolo affinché possano riportarne qualche profitto da usare a suo onore ed a lode del nostro Redentore Gesù Cristo, al quale sia onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Così sia.
II – VERO METODO PER LEGGERE I LIBRI DEI FILOSOFI NATURALI.
Aristotele, nel primo libro della Fisica, ci ha insegnato che non bisogna disputare contro coloro che negano i principi della scienza, ma piuttosto contro coloro che li professano, quando propongono diversi argomenti che non possono risolvere a causa della loro ignoranza, rimanendo sempre in dubbio. È dunque per costoro, e non per gli altri, che, seguendo l’esempio del mio buon maestro, io scrivo. Perché come afferma lo stesso autore, disputare con simile genia di persone, equivale a discorrere dei colori con dei nati ciechi che, non avendo il mezzo (ossia la vista) per giudicarne, non potranno essere persuasi che esistono colori diversi.
Perciò, affinché i buoni fedeli e figli sinceri possano riportare un qualche profitto dal mio Opuscolo, trovando in esso sollievo e riposo dello spirito, mi sono penato, più che mi sia stato possibile e per quanto il soggetto stesso della nostra scienza lo permette, di redigere la seconda parte in forma di vero e proprio metodo, al fine di evitare la grande varietà e confusione che ordinariamente si presenta nella lettura dei libri dei filosofi. Il che mi porta ad usare il medesimo ordine che ho osservato nel mio stesso studio, procedendo per suddivisioni, come segue:
1. Per prima cosa mostreremo, con l’aiuto del nostro buon Dio, da chi è stata inventata la nostra scienza e di quali autori abbiamo fatto uso nella compilazione del presente Opuscolo, chiarendo la ragione del perché essi abbiano scritto tanto enigmaticamente.
2. Proveremo poi la verità e la certezza di questa scienza con diversi argomenti, rispondendo alle ragioni più evidenti che si sogliono sollevare per provare il contrario; il lettore diligente potrà così confrontare, dalle altre sezioni della nostra suddivisione, e particolarmente dalla terza e quarta parte, ciascuna delle nostre soluzioni con gli argomenti contrari che si potrebbero opporre.
3. Per terza cosa, proveremo in cosa la nostra scienza è naturale e perché è chiamata divina, parlando delle sue operazioni principali; qui dichiareremo gli errori degli odierni operatori.
4. Ciò fatto, dedurremo il modo in cui, sotto terra, lavora la natura, mostrando in cosa l’arte può seguire la natura nelle sue operazioni.
5. Poi, dichiareremo la vera materia che si richiede per fare i metalli sopra la terra.
6. Chiariremo, infine, i termini principali della nostra scienza, accordando le sentenze più necessarie dei filosofi che appaiono più contraddittorie, e leggendo i loro libri.
In tal modo i sinceri amatori della nostra scienza potranno riportare un grande profitto, mentre i nostri invidiosi ordinari detrattori otterranno invece, dal presente opuscolo, grande confusione; ho voluto confermare il mio scritto con le autorità dei più sapienti ed antichi filosofi e buoni autori, affinché i detrattori non prendano a pretesto il fatto che è un autore nuovo che svela la loro empietà e i loro continui inganni.
1 – DEI PRIMI INVENTORI DI QUESTA SCIENZA.
Per dire quali siano stati i primi inventori della nostra scienza, ci occorre ricordare la dottrina che l’apostolo San Giacomo ci ha lasciato scritta nella sua canonica, e cioè che tutto ciò che è buono ed ogni bene che è perfetto ci è dato dall’alto, discendendo dal padre della luce che è l’eterno Dio. Il che non voglio adattare al nostro soggetto nei termini generali che si potrebbero usare per tute le cose create, ma in termini specifici; io dico che la nostra scienza è tanto divina e sopranaturale (intendo nella seconda operazione, come sarà più ampiamente spiegato nella terza parte della nostra suddivisione) che è stato sempre impossibile, e sempre lo sarà in avvenire ad ogni uomo, il conoscerla e scoprirla da solo, fosse egli anche il più grande ed esperto filosofo che ci sia al mondo. Infatti tutte le ragioni ed esperienze naturali in ciò falliscono, di modo che, è stato giustamente scritto dagli autori antichi, questa scienza è il segreto che il buon Dio ha riservato e donato a coloro che lo temono ed onorano, come dice il nostro filosofo Hermes: Io non posseggo questa scienza per altra via che attraverso l’ispirazione di Dio. Il che è confermato da Alphidius, che dice: sappi, figlio mio, che il buon Dio ha riservato questa scienza per i posteri di Adamo, e principalmente per i poveri ed i ragionevoli. Geber ha affermato lo stesso nella sua Summa, dicendo: la nostra scienza è nella potenza di Dio il quale, essendo giusto e benigno, la dona a chi vuole. Essa è dunque tutt’altro che in potere degli uomini, e tanto meno è stata da essi inventata, in quanto che è sovrannaturale.
Ma, rispetto al fatto che essa è pure opera naturale, vale a dire che nelle sue prime operazioni essa segue la natura, vi sono diverse opinioni al riguardo di chi ne sia stato il primo inventore. Gli uni dicono che fu Adamo, gli altri Esculapio, gli altri dicono che fu Enoch a conoscerla per primo, mentre altri vogliono che fosse Ermete, tanto lodato dai Greci, cui essi hanno attribuito l’invenzione di tutte le scienze occulte e segrete. Per parte mia, concorderei volentieri con questa opinione, poiché è abbastanza noto che Ermete fu un grandissimo filosofo, come è testimoniato dalle sue opere; essendo tale, egli ha diligentemente investigato le cause delle esperienze e delle cose naturali, attraverso la cui conoscenza ha potuto conoscere la vera materia che la natura usa nelle cavità della terra per la procreazione dei metalli. Credo ciò poiché tutti coloro che lo hanno seguito sono pervenuti, per suo mezzo, alla vera conoscenza di quest’opera divina, come è stato per Pitagora, Platone, Socrate, Zenone, Haly, senior Razi, Geber, Morieno, Bono, Arnaldo da Villanova, Raimondo Lullo e molti altri che sarebbe lungo elencare. Dai principali di questi autori, noi abbiamo raccolto ed assemblato il materiale del presente Opuscolo, ma con gran fatica, perché, come i loro libri possono testimoniare, essi hanno scritto in modo tale (avendo sempre il timor di Dio innanzi agli occhi) che è pressoché impossibile il pervenire alla conoscenza di questa divina opera attraverso la lettura dei loro scritti, come dice Geber nella sua Summa: non bisogna – egli dice – che il figlio della scienza si disperi e diffidi della conoscenza di questa opera divina, perché, cercando e pensando ordinariamente alle cause dei composti naturali egli vi perverrà. Ma colui che si attende di trovarla attraverso i nostri libri, vi perverrà assai tardi. Perché – dice in un altro luogo – i filosofi hanno scritto la vera pratica per se stessi, mescolando tra loro i modi di investigare le cause per arrivare alla sua perfetta conoscenza. Il che ha fatto si che egli mettesse nella sua Summa le operazioni principali e le cose richieste alla nostra divina opera in vari e diversi capitoli: poiché – egli dice – se li avessi messi per ordine e seguito, essa sarebbe conosciuta da tutti in un giorno, o anche in un’ora, tanto essa è nobile e mirabile. Lo stesso ha detto Alphidius, scrivendo che i filosofi che ci hanno preceduto hanno nascosto la loro principale intenzione sotto diversi enigmi ed innumerevoli equivoci, affinché, attraverso la pubblicazione delle loro dottrine, il mondo non fosse rovinato; come in effetti lo sarebbe, perché ogni esercizio dei lavori e di coltivazione della terra, ogni commercio, e, in breve, tutto ciò che è necessario alla conservazione della vita umana, sarebbe perduto, poiché nessuno se ne vorrebbe più occupare, avendo in suo potere un bene tanto grande quanto questo. Perciò Ermete, scusandosi all’inizio del suo libro, dice: figli miei, non pensiate che i filosofi abbiano nascosto questo grande segreto per l’invidia che essi portano ai sapienti ed ai ben istruiti, ma piuttosto per nasconderlo agli ignoranti e maliziosi. Poiché diversamente, come dice Rosinus: l’ignorante sarebbe fatto simile al sapiente, ed il malizioso e malvagio ne userebbero a danno e rovina di tutto il popolo. Simili motivi sono riportati da Geber nella sua Summa al capitolo della somministrazione della medicina solare, quando dice che: bisogna che i figli della dottrina non si meraviglino se i filosofi hanno parlato nascostamente nei loro libri. Non è per nascondere loro il vero, ma per celare, sotto tanta varietà e confusione di operazioni, il loro segreto agli ignoranti, e, ciò nonostante, indirizzare e guidare i figli della scienza alla sua conoscenza. Perciò – egli scrive in altro luogo – essi non hanno scritto la scienza se non per se stessi, dando tuttavia i mezzi per comprenderla.
È questa la ragione per la quale tutti i libri dei filosofi sono pieni di grandi difficoltà, e dico grandi perché esse sono innumerevoli. Perché cosa è più difficile da vedere al mondo se non il risolvere una così grande contraddizione tra tanti autori rinomati e sapienti? O anche il trovare contraddizioni di dottrina all’interno di un singolo autore? Il che è testimoniato dagli scritti di Razi, quando, nel libro delle Luci, egli dice: Ho mostrato abbastanza, nei miei libri, il vero fermento richiesto per le moltiplicazioni delle tinture dei metalli, il quale in altro luogo ho affermato non essere il vero lievito, lasciandone la vera conoscenza a colui che avrà ingegno abbastanza buono e sottile da riconoscerlo.
D’altra parte, se l’uno scrive che la nostra vera materia è di prezzo vile e da nulla, trovata tra il letame, come dice Zenone nella Turba dei filosofi, immediatamente, nello stesso libro, un altro, Barseus, dice: quel che cercate non è di poco prezzo. L’altro dirà che essa è assai preziosa e non si può trovare che a gran prezzo.
Anzitutto, se uno ha appreso a preparare la nostra materia in diversi vasi e diverse operazioni, come ha fatto Geber nella sua Summa, ve ne sarà un altro che assicurerà che non vi è bisogno che di un vaso per perfezionare la nostra opera divina, come dicono Razi, Lilium, Alphidius e molti altri.
Poi quando si leggerà in un libro che bisogna rimanere nove mesi sulla procreazione a completamento della nostra divina opera, come ha scritto lo stesso Razi, si leggerà in un altro che occorre un anno, come dicono Rosinus e Platone.
Si troveranno termini tanto diversi e variabili (in apparenza, intendo) e mal spiegati che è impossibile agli uomini, come dice Raimondo Lullo, scoprire la verità tra tante diverse opinioni, se il buon Dio non ci ispira attraverso il suo Spirito Santo o non ce la rivela attraverso qualche persona vivente. Il motivo per cui non veniamo mai a conoscenza di nessuno che abbia realizzato l’opera, venendone a sapere solo dopo la loro morte, è che, avendola essi ottenuta con gran pena, se fosse possibile la celerebbero persino a se stessi, e giammai la rivelerebbero ad altri. Quindi, seguendo le ragioni fin qui esposte, non bisogna trovare strano, come fa il volgo, il non vedere nessuno che abbia compiuto questa divina opera, e bisogna piuttosto meravigliarsi, come fanno i sapienti, che qualcuno sia pervenuto alla sua vera conoscenza.
2 – DELLA CERTEZZA E VERITÀ DELLA SCIENZA.
Ma, proseguendo nell’ordine in cui abbiamo cominciato, bisogna affrontare il secondo punto della nostra suddivisione, ossia se la nostra scienza sia certa ed autentica. Tuttavia, prima di cominciare, bisogna che io contenti le delicate orecchie dei calunniatori i quali, per esser soliti rimproverare i lavori d’altri (dal momento che i loro non vedono mai la luce), diranno che io ho mal appreso la dottrina di Aristotele che, nel settimo libro della Fisica, ha scritto: la definizione è la vera forma del soggetto definito. E così, poiché ho intrapreso a trattare la spiegazione ed il vero metodo di questa scienza (comunemente chiamata alchimia) devo cominciare dalla sua definizione per meglio chiarire il significato dei suoi termini. Ma rinvierò volentieri, per questo argomento, agli autori che mi hanno preceduto, i quali, essendosi prefissi di darne certa definizione, sono stati costretti a confessare che ciò era impossibile, come testimoniano, ad esempio, gli scritti di Morieno, Lilium e diversi altri. In ragione di ciò, essi hanno, nei loro libri, assegnato diverse e varie descrizioni con le quali mostrano gli effetti della nostra scienza, poiché essa non si basa affatto su principi familiari ai più come tutte le altre scienze.
Da parte mia, ne dirò ciò che credo: è una parte della filosofia naturale, la quale mostra il modo di perfezionare metalli sulla terra, imitando il più possibile la natura nelle sue operazioni. Questa scienza noi la diciamo certa per diverse ragioni:
1. Anzitutto, è ritenuto certo presso tutti i filosofi che non vi sia nulla di più sicuro della verità che appare, come dice Aristotele, laddove non c’è contraddizione. Così tutti i filosofi hanno scritto di questa divina filosofia seguendosi gli uni con gli altri, alcuni scrivendo in ebraico, altri in greco, altri in arabo, latino e diversi altri linguaggi; essi si sono talmente intesi ed accordati tra loro, sebbene abbiano scritto sotto il velo di equivoci e figure (per le ragioni descritte sopra) che si giurerebbe con buona ragione che essi abbiano scritto in un medesimo tempo e con medesima lingua, mentre essi hanno invece scritto gli uni a cento anni, gli altri a duecento o anche a mille anni di distanza gli uni dagli altri, come dice Senior: i filosofi sembrano aver scritto di cose diverse sotto diversi nomi e similitudini, mentre, in verità, essi non hanno mai inteso che un’unica e stessa cosa. Di ciò abbiamo un’altra testimonianza evidentissima nel fatto che gli stessi che hanno scritto libri di grande sapienza in altre scienze, ne hanno scritto anche in questa, che nei loro scritti affermano essere autentica.
2. Quand’anche non avessimo altra prova che la sentenza del Filosofo che dice, al 2° dell’Etica, che ciò che è ben fatto, si compie per un mezzo, ciò sarebbe sufficiente per assicurarci della verità della nostra scienza. Infatti tutti coloro che hanno scritto di essa si accordano sul fatto che non vi è che una sola via per perfezionare la nostra opera divina, come Geber dice nella sua Summa: la nostra scienza non si porta a perfezione mediante diversità di cose, ma per mezzo di una sola, nella quale noi non aggiungiamo né diminuiamo alcunché, al di fuori delle superfluità che separiamo nella sua preparazione. Lo stesso testimonia Lilium, quando scrive che tutto il nostro magistero si porta a perfezione per mezzo di una sola cosa, con un solo regime ed un solo mezzo. Altrettanto ne hanno scritto tutti gli altri filosofi, benché le loro sentenze possano apparire discordanti.
3. Inoltre teniamo per più che vera l’autenticità della nostra scienza, grazie all’esperienza certissima che abbiamo visto, che, per quel che ci riguarda, è l’assicurazione principale, come dicono Razi e Senior.
4. Ma, per dimostrarla come tale il meglio possibile a coloro che potrebbero giustamente dubitarne, bisogna concordare con tutti i filosofi che la nostra scienza è compresa sotto la parte della filosofia naturale che essi hanno definito abbastanza propriamente operativa, apparentandola in ciò con la medicina. Ora, della medicina non si può dimostrare la verità e la certezza che per mezzo dell’esperienza. E che essa sia vera, quando leggiamo nei suoi libri che ogni collera è evacuata dal rabarbaro, noi non possiamo stabilirlo prima che l’esperienza ce lo dimostri; solo questa può dimostrare che la collera è guarita dall’applicazione di quel determinato semplice. Così, parlando per analogia (benché la nostra divina opera non possa essere comparata ad alcunché), diremo che, se l’esperienza ci mostra che il fumo di piombo o quello di atramento congelano l’argento vivo, ciò ci certifica (e ci induce a credere) che è possibile preparare una medicina perfettissima, simile alla qualità naturale dei metalli, e che con essa possiamo fissare l’argento vivo e perfezionare, per proiezione, gli altri metalli, assumendo che i composti minerali imperfetti congelano l’argento vivo riducendolo al loro stato naturale. A maggior ragione, dunque, i perfetti, per mezzo della nostra arte e debitamente preparati da questa, congeleranno e ridurranno a stato simile al proprio tutti gli altri metalli imperfetti, con grande ed esuberante decozione somministrata dalla nostra arte.
5. E per contentare ulteriormente i curiosi d’oggi, addurremo qualche altro argomento per meglio indurli a credere alla verità della nostra scienza. È certo che tutto ciò che compie la medesima operazione di un composto è del tutto simile a questo, come dice Aristotele nel 4° libro delle Meteore, quando dichiara che tutto ciò che compie le operazioni di un occhio, è un occhio. Dunque il nostro oro (ovvero quello che fabbrichiamo per mezzo della nostra divina opera) è del tutto simile all’oro minerale, e, nonostante tutti i dubbi odierni consistano nel verificare se l’oro che fabbrichiamo è perfetto, mi sembra di aver dimostrato sufficientemente (seguendo l’autorità dei filosofi) che la nostra scienza è certissima. È vero d’altronde, si dirà, che le mie prove sono sufficienti solo per coloro che hanno avuto esperienza della nostra scienza, mentre non lo sono per gli altri, ad uso dei quali, affinché neanche essi abbiano alcun dubbio, esporrò le ragioni seguenti.
6. Aristotele, nel 4° libro delle Meteore, nel capitolo delle digestioni, dice che ogni cosa che sia predisposta per essere perfetta, ma che manifesti mancanza di digestione, può essere, mediante continua digestione, resa perfetta. Dunque tutti i metalli imperfetti sono rimasti tali per mancanza di digestione, perché essi sono stati fatti per essere alla fine convertiti in oro e, per questa via, essere perfetti, così come ci testimonia l’esperienza e come descriveremo in seguito, nel quarto punto della nostra suddivisione. Essi dunque potranno essere perfezionati per mezzo della continua decozione che la natura fa nelle cavità della terra. La nostra arte li perfeziona sulla terra per mezzo della proiezione della nostra divina opera, come spiegheremo più innanzi nel penultimo punto della nostra suddivisione.
7. Inoltre, se i quattro elementi, che per alcune qualità sono tra loro contrari, come dice Aristotele nel 2° libro delle Generazioni, sono convertiti gli uni negli altri, a maggior ragione lo saranno i metalli, che sono tutti d’una medesima materia e, tra le altre cose, non contrari quanto alle qualità. È questa la ragione per la quale Ermete ha definito la loro procreazione circolare, un po’ impropriamente, come egli stesso dice, perché i metalli non sono procreati dalla natura per ritornare da perfetti a imperfetti, di modo che l’oro divenga piombo o l’argento stagno, ma piuttosto per essere fatti perfetti con ordine e continua decozione, sino a che siano perfetti, divengano oro, come l’esperienza dimostra evidentemente. Così, la loro generazione non è completamente circolare, per quanto in parte lo sia.
Queste ragioni ed altre simili (che al momento tralascio, poiché questo mio piccolo Opuscolo non può comprendere ogni discorso che potrebbe svilupparsi su questo argomento) sarebbero sufficienti per dimostrare la verità e la certezza della nostra scienza, non fosse che al riguardo degli argomenti avversi che si è soliti sollevare e che turbano talmente gli intelletti dei figli della dottrina, che essi sono sempre in dubbio, credendo ora all’uno, ora all’altro, in modo da non aver mai riposo nel loro spirito. Ma, affinché essi possano credere verissima la nostra scienza, voglio rivelargli la vera soluzione del più violento ed evidente argomento che si è soliti sollevargli contro, e così i figli della dottrina riconosceranno che le loro obiezioni e tutte le altre simili non posseggono che la sola apparenza della verità.
Tutti sogliono portare un’obiezione che si fonda sull’autorità del Filosofo, che, nel quarto libro delle Meteore, la quale obiezione è condivisa da Avicenna come dice Alberto Magno: invano lavorano gli operatori d’oggi nel perfezionare i metalli, poiché essi non vi riusciranno mai se prima non li riducono nella loro prima materia. Quando non li riduciamo, non facciamo altro che sofisticazioni, come scrive lo stesso Alberto, dicendo: tutti coloro che colorano i metalli con varie specie di semplici e con diversi colori, senza prima ridurli nella loro prima materia, in verità non sono che imbroglioni ed ingannatori.
Da parte mia, so bene che molti sapienti hanno discusso questo argomento, poiché è il più appariscente che ci sia. Alcuni osservano che, proiettando la nostra divina opera sui metalli imperfetti, noi non riduciamo affatto questi ultimi nella loro prima natura: tuttavia, se nella sua composizione, noi l’avevamo ridotta in zolfo ed argento vivo, che sono la vera materia dei metalli (come spiegheremo nella quarta parte della nostra suddivisione) per la gran perfezione acquisita durante la decozione, essa è poi sufficiente a condurre a perfezione tutti i metalli imperfetti per proiezione, senza ridurli prima alla loro materia prima. Tale era l’opinione di Arnaldo da Villanova nel suo Gran Rosario, che fu seguito da Raimondo Lullo nel suo Testamento.
Ma, fatto salvo l’onore e la reverenza dovuti a questi due sapienti personaggi, mi pare che dire ciò sia parlare contro l’opinione di tutti i filosofi; infatti, poiché essi concordano con la necessità di ridurre i metalli nella loro prima materia (il che si compie per movimento e corruzione come dice Aristotele) essi vogliono far intendere che, attraverso la sola fonte e proiezione della nostra divina opera sui metalli, essi siano corrotti e privati delle loro prime forme, il che è un pensiero indegno di ogni filosofo. Altri ancora, come si può desumere dai loro libri, hanno proposto diverse e varie soluzioni.
Quanto a me, dirò quel che ne penso: è verissimo che, se volessimo fare metalli ex novo, o anche se volessimo fare da essi terre, pietre o altre cose simili, totalmente differenti dai metalli stessi, noi dovremmo sicuramente ridurli nella loro materia prima nel modo precedentemente descritto; ma, poiché non vogliamo che condurre alla perfezione dell’oro dei metalli imperfetti, senza trasformarli in nuove materie differenti dalla loro propria natura, e piuttosto purgarli e pulirli attraverso la proiezione della nostra divina opera affinché mediante la grande ed esuberante perfezione di questa siano condotti a perfezione, allora non c’è affatto bisogno di ridurli alla loro prima materia. È infatti notissimo che il perfezionare l’imperfetto ed il produrre ex novo sono due cose del tutto differenti. In caso contrario, ne conseguirebbe che bisognerebbe rimettere ogni cosa semi-cotta nella sua prima materia per completarne la cottura, il che è pensiero indegno di ogni filosofo.
Quanto alle altre obiezioni che si è soliti sollevare, al presente io taccio, poiché le soluzioni ad esse si trovano nei libri di buoni autori ed, inoltre, il lettore diligente e studioso, potrà, per la maggior parte, trovarle da solo, tanto avendo presente ciò che già abbiamo detto quanto leggendo ciò che diremo in seguito, visto e considerato che abbiamo già risolto l’obiezione più complessa e difficile da risolvere. Con ciò, tuttavia, non voglio dimenticare l’autorità di Avicenna il quale, parlando della giovanile contraddizione di Aristotele rispetto alla dottrina di tutti i filosofi antichi, dice: non ho scuse legittime, poiché conosco sia il pensiero di coloro che negano la nostra scienza che di coloro che la stimano vera. I primi come Aristotele ed altri, usano delle ragioni che hanno una certa evidenza ma non sono vere. Gli altri ne hanno addotte altre, ma assai lontane da quelle che si è soliti considerare nelle altre scienze. Con ciò egli voleva dire che la nostra scienza non può essere provata da dimostrazioni certe, come tutte le altre, poiché essa procede in modo diverso, del tutto contrario alle altre, celando e nascondendo i significati dei suoi termini laddove le altre si sforzano di chiarirli.
3 – CHE LA SCIENZA È NATURALE, DEL PERCHÉ È CHIAMATA DIVINA E QUALI OPERAZIONI SONO NECESSARIE ALL’OPERA.
Continuando con ordine nella mia divisione, affronterò la sua terza parte, mostrando quali operazioni sono necessarie per compiere la nostra divina opera, anzitutto chiarendo in che modo la nostra scienza è naturale e perché essa è chiamata divina. Si potranno così riconoscere i grandi e pesanti errori degli operatori attuali.
Per comprendere bene in cosa la nostra scienza sia naturale, bisogna sapere ciò che Aristotele ha insegnato delle operazioni della natura. Egli ha ben mostrato che essa lavora sotto terra nella procreazione dei metalli delle quattro qualità o (per parlare più semplicemente) dei quattro elementi chiamati fuoco, aria, acqua e terra, dei quali due contengono gli altri due, ovvero la terra che contiene il fuoco e l’acqua che contiene l’aria. Pertanto, poiché la nostra materia è fatta d’acqua e di terra (come diremo nell’ultima parte della nostra suddivisione) essa è detta giustamente naturale, perché nella sua composizione vi entrano i quattro elementi; di essi due sono nascosti agli occhi corporali, ovvero il fuoco e l’aria, che bisogna vedere con gli occhi dell’intelletto come dice Raimondo Lullo nel suo Codicillo: considera bene – egli dice – in te stesso la natura e proprietà dell’olio che i sofisti hanno chiamato aria (poiché dicono che maggiormente abbonda di una tal qualità) dal momento che il tuo occhio non ti mostrerà le sue differenze e proprietà. Con ciò egli ci mostra che i quattro elementi non sono tutti evidenti nella nostra opera, come molti hanno falsamente stimato, secondo ciò che diremo più oltre spiegando i termini della nostra scienza.
Inoltre, essa è detta naturale perchè nella sua prima operazione imita la natura il più possibile, dal momento che non potrebbe imitarla in tutto, come dice Geber nella sua Summa; e che ciò sia vero ce lo assicurano i filosofi naturali che ci hanno preceduti. Essi, ad esempio Raimondo Lullo nella sua Epistola a re Roberto e Alberto Magno nel suo Trattato dei minerali, hanno diligentemente investigato che il modo con cui la natura lavora sotto terra nella procreazione dei metalli non è altro che la continua decozione della loro materia prima; decozione che separa il mondo dall’immondo, il puro dall’impuro, il perfetto dall’imperfetto per evaporazione continua causata dal calore della terra minerale in parte scaldata dal calore del sole. In effetti la natura, da sola, non compie l’intera e perfetta decozione, così come assai bene ha spiegato il buon Trevisano e come l’esperienza nelle miniere ordinariamente ci mostra; in esse si trovano infatti diversità di metalli e materie, le une grossolane, le altre pure e sottili, che volentieri sono elevate più in alto. La nostra scienza dunque, imitando in ciò la natura, all’inizio, nella sua prima operazione, per purificare assai bene la nostra materia, procede per sublimazione, dal momento che le sarebbe impossibile prepararla altrimenti, come dicono Geber nella sua Summa e Razi nel libro Delle Luci, quando dice: l’inizio dell’opera è sublimare. Ciò è detto con buone ragioni naturali.
Ciò ha fatto scrivere a coloro che ci hanno preceduti che la nostra opera divina non è affatto artificiale, perché ciò che facciamo è condurre con l’arte alla natura la dovuta materia, non potendo la natura giungere, con azione continua, alla perfezione della nostra divina opera.
A ragione della mirabile congiunzione degli elementi, la nostra opera si chiama divina. Tale congiunzione è stata chiamata dai filosofi seconda operazione, ed altri l’hanno invece chiamata dissoluzione, dicendo che essa costituisce il segreto dei segreti. Pitagora ne dice: è il grande segreto che Dio ha voluto nascondere agli uomini; Razi, nel libro delle Luci, dice: se ignori la vera dissoluzione del nostro corpo, non cominciare a lavorare, perché se ignori questo tutto il resto è inutile. Tale operazione è del tutto impossibile da conoscere attraverso i libri, ad essa si arriva per la conoscenza delle cose naturali, il che costituisce la ragione per cui la nostra scienza è chiamata divina, come dice Alessandro: il nostro corpo (che è la nostra pietra nascosta), senza il quale la nostra scienza è perduta, non può da noi essere conosciuto né visto se il buon Dio non ci ispira attraverso il suo Spirito Santo o ce lo svela attraverso una persona vivente. È la pietra della quale parla Ermete nel suo quarto trattato, quando dice: bisogna conoscere la nostra divina e preziosa pietra, la quale crea incessantemente: difendimi ed io ti aiuterò, rendimi i miei diritti ed io ti soccorrerò. Di questo medesimo corpo nascosto, egli parla nel suo primo trattato, quando dice: il falcone è sempre sul limite delle montagne e grida: io sono il bianco del nero ed il rosso del citrino.
La ragione per la quale la nostra scienza è inutile senza la detta congiunzione, è che alla nascita e procreazione della nostra opera divina, la parte volatile trascina con sé la fissa. In tal modo, noi non sapremmo fare in modo che essa restasse fissa e permanente all’azione del fuoco, senza far si, attraverso una mirabile (ossia soprannaturale) congiunzione, che il fisso ritenga il volatile, affinché sia compiuto ciò che tutti i filosofi comandano, ossia rendere il fisso volatile ed il volatile fisso. Questa congiunzione si deve compiere nel medesimo istante della sua nascita, come dice Haly nel libro dei suoi Segreti: colui che non troverà la nostra pietra nell’istante della sua nascita, è inutile che attenda altro momento, poiché colui che ha intrapreso la nostra opera divina senza conoscere l’ora determinata della sua nascita, non ne riporterà che pena e tormento. Questa medesima congiunzione è assai propriamente chiamata da Razi peso e regime dei filosofi; egli consiglia che, laddove non la si conosca assai bene, si eviti del tutto di lavorare alla nostra divina opera, dicendo che i filosofi nulla hanno nascosto con maggior cura. Cosa che è del resto ben dimostrata nei loro scritti. Infatti, se uno dice che questa divina opera deve essere compiuta nel settimo giorno, l’altro dice al quarantesimo, un altro al centesimo, uno nel volgere di sette mesi, un altro – come Razi – nel volgere di nove, un altro ancora – come Rosinus – nel tempo di un anno. Non ve ne sono due che concordino, quando, in realtà, non vi è che un solo termine, un sol giorno, una sola ora nella quale bisogna compiere, per decozione, la nostra congiunzione. Tuttavia per l’invidia che essi hanno di tenerla segreta, essi hanno di proposito e deliberatamente scritto termini temporali differenti gli uni dagli altri, ancorché concordassero assai bene, tra loro, sul fatto che non vi è che un solo termine e che, saputo questo, il resto non è che lavoro di donne e gioco da bambini, come dice Socrate: ti ho mostrato la vera disposizione del piombo bianco, vale a dire la vera composizione della nostra materia, che, al principio, appare nera e di piombo, ed è poi fatta bianca attraverso la nostra continua decozione. Se tu la conosci bene, il resto non è che lavoro di donne e gioco da bambini, il che vuol dire che, dopo la detta congiunzione, in verità, non vi è opera più facile della nostra. E poiché non vi è bisogno che di cuocere le due materie già assemblate, durante la detta decozione si è a riposo, ed è certissimo che è un impegno molto piacevole, dal momento che, come dice anche Aristotele nel 2° dell’Etica, vi è più piacere nel riposarsi che nel lavorare.
E che ciò sia vero o conferma Razi che, nel libro delle Tre Parole, dice che ogni dissoluzione, calcinazione, sublimazione, albificazione, rubificazione ed ogni altra operazione che i filosofi hanno descritto come necessaria a perfezionare la nostra divina opera, si compie nel fuoco, senza muoversi. Pitagora dice il medesimo nella Turba, scrivendo che tutti i regimi richiesti alla perfezione della nostra divina opera sono realizzati attraverso la sola decozione. Nello stesso libro Barsenne dice che nella nostra divina opera bisogna cuocere tingere e calcinare, ma tutte queste operazioni si compiono con la sola decozione.
Tuttavia, affinché i nostri calunniatori non dicano che tutte le loro operazioni non sono altro che decozioni, voglio loro allegare altre sentenze dei filosofi antichi per togliergli ogni scusa ed additare ai loro occhi la loro stessa ignoranza ed il loro errore.
Alfidio ci testimonia che non abbiamo bisogno, nella composizione della nostra opera divina, che di una sola materia, che egli chiama propriamente acqua, e di una sola azione, che è la cottura, la quale si compie in un solo vaso, senza che nulla si tocchi.
Il re Salomone testimonia il medesimo, quando dice che per il compimento della nostra opera divina, che egli chiama nostro zolfo, non abbiamo che un sol mezzo.
Lilium ha scritto lo stesso, dicendo che la nostra divina opera si fa in un solo vaso, con un sol mezzo ed una sola cottura.
Maometto dichiara il simile dicendo che non abbiamo che un solo mezzo, ossia la cottura, ed un sol vaso in cui fare la nostra divina opera, sia la bianca che la rossa.
Avicenna è stato della medesima opinione quando, parlando più propriamente d’altri, disse che tutte le disposizioni, ovvero le operazioni, richieste alla composizione della nostra divina opera, si compiono in un sol doppio vaso.
Se dunque è vero che la nostra divina opera si compie in un sol doppio vaso e con una sola cottura, bisogna che la maggior parte degli operatori odierni confessino le proprie mancanze ed errori, poiché non ne ho visto nessuno che non utilizzasse tre o quattro fornelli. Ce ne erano alcuni che, per perfezionare la loro opera, ne avevano dieci o dodici, uno per distillare, l’altro per calcinare, uno per dissolvere, l’altro per sublimare, insieme ad un’infinità di vasi. Ma costoro sono ancora a un punto morto, e vi rimarranno sempre se non correggono i loro errori.
Taccio sull’ammasso di separazioni che essi praticano, a loro dire, sui quattro elementi, poiché sarà d’uopo occuparcene quando spiegherò la natura dei quattro elementi, quando chiarirò i termini della nostra scienza. Al momento mi è sufficiente aver mostrato la maniera e modo autentico per riconoscere, quasi come additandoli, quelli che sono lontani dalla verità della nostra scienza, per distinguerli da coloro che sono nel vero cammino. Perché, come abbiamo mostrato sopra ed ancora, più appresso, mostreremo, non vi è che un solo mezzo, un sol modo di fare, e ciò deve avvenire in un sol vaso (che Raimondo Lullo chiama himen) e con un solo fornello (che il buon Trevisano chiama fuoco chiuso, umido vaporoso, continuo e digerente) senza mai toccar nulla, fino a che la decozione non sia perfetta. E non c’è certo bisogno dei tanti guazzabugli e delle tanto folli spese che si è soliti fare.
Non ignoro affatto che, tra essi, ve ne possano essere alcuni che, avendo letto i libri ed essendo veri Chierici (poiché lavorano tutti a credito), diranno: perché ci accusi in questo modo, visto che Geber, nella sua Summa, ci insegna diverse preparazioni, tanto di zolfo che di argento vivo, insieme del corpo e dello spirito? E Razi, nel libro del Perfetto Magistero, testimonia che il corpo e gli spiriti sono preparati con modi diversi e ne insegna la maniera. Ma non debbo penar molto per rispondergli, poiché gli ho già risposto con ciò che ho detto in precedenza. Perché tali e simili passi sono stati scritti per nascondere la vera preparazione della nostra divina opera, come abbiamo detto nella prima parte della nostra suddivisione. Il che lo stesso Geber testimonia nella sua Summa, al capitolo delle differenze delle medicine: vi è, egli dice, una sola via perfetta la quale ci alleggerisce e ci solleva dal nostro penare in tante altre preparazioni.
Note della Bibliothèque des Philosophes Chimiques.
(1) Zachaire ha scritto in francese il suo Opuscolo, e pertanto non si è creduto doverne riformare il linguaggio per le ragioni che hanno impedito di correggere anche quello del Trevisano.
Note del traduttore:
[A] L’autore gioca in maniera intraducibile tra receptes (ricette), e déceptes (delusioni, inganni).
[B] Denis mostra qui di essere perfettamente consapevole di uno dei meccanismi più diffusi della pseudoepigrafia nella tradizione testuale dell’alchimia. Cfr. R. Halleaux, Les Textes Achimiques, (Brepols, 1979) pp. 97-100.
[C] L’autore usa anche qui déceptes, richiamando il gioco di parole precedente.