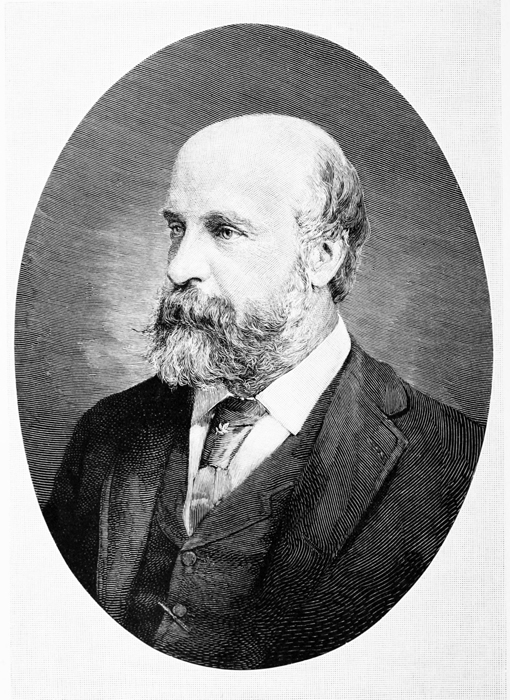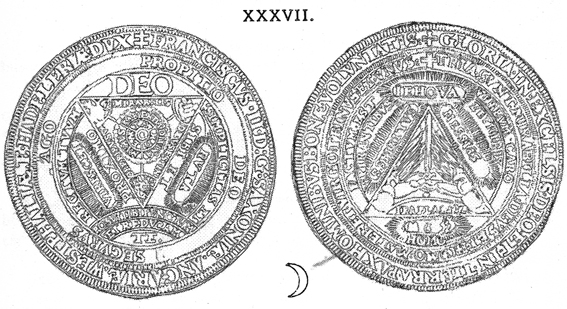Una foto giovanile di Auguste Bouché-Leclercq (fonte Wikipedia)
Auguste Bouché-Leclercq (Francières 1842-Nogent-sur-Marne 1923, secondo alcune fonti 1924), storico, erudito impareggiabile e studioso della civiltà antiche, viene abitualmente citato come primo indagatore della storia dell’astrologia. Professore nelle università di Parigi e di Montpellier, dal 1898 membro della prestigiosa Acàdemie des inscriptions et belles-lettres¸ a lui si debbono contributi assai rilevanti sulla storia delle scienze divinatorie nel mondo antico, studi ancor oggi fondamentali e di sicura referenza per gli studiosi. In particolare due opere, Histoire De La Divination Dans L’Antiquité (1879) e L’astrologie grecque (1899) rimarranno opere di referenza imprescindibili per intere generazioni di studiosi. L’impostazione ingenuamente positivista – spesso colorita d’ironia, ricca di spunti critici ed annotazioni fortemente connotate storicamente – di questi del Bouché-Leclercq, insieme ad un tono generale di anticlericalismo, sono tratti tipici di una larga generazione di studiosi a cavallo tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo. Pur essendo talvolta superato sul piano storiografico e, soprattutto, su quello ermeneutico, il lavoro di Bouché-Leclercq permane di grande valore storico e di grande spessore ed utilità.
Il seguente testo, che proponiamo al lettore in prima traduzione italiana, è stato pubblicato in due forme, dapprima nella Revue Historique, (anno 22, tome 65, sept.-Dec. 1897), e, contemporaneamente, come estratto. Si tratta di un capitolo de L’astrologie Greque, come lo stesso autore in nota tiene a precisare. In questa edizione abbiamo eliminato alcune note che riportano il testo greco originale delle traduzioni citate dal Bouché-Leclercq, per evitare l’obbligo di adozione di appositi fonts per visualizzare correttamente il testo. Il lettore interessato potrà reperirle nell’edizione originale francese reperibile grazie al progetto Gallica della BNF. L’intera versione in PDF della monumentale L’astrologie Greque è invece reperibile all’indirizzo:
http://www.hellenisticastrology.com/critical%20editions/Bouche-Leclercq-Lastrologie-grecque.pdf
Laddove reso possibile dalla mappa di caratteri speciali normalmente inclusa nei fonts standard di Windows, le citazioni e i riferimenti in greco sono stati conservati.
Il valore di questo sommario storico delle dottrine astrologiche, che esplora un arco di secoli ampio, affrontato con dovizia di riferimenti alle fonti primarie, come si è accennato, rimane oggi immutato, soprattutto per quanto riguarda la storia della polemica antiastrologica. Il lettore italiano desideroso di approcci alla storia dell’astrologia può oggi accedere ad alcuni testi più recenti, quali ad esempio quello di Jim Tester, Storia dell’astrologia Occidentale: dalle origini alla rivoluzione scientifica (ECIG, 1999), o quello, ancor più recente, di Kochu von Stuckrad, Storia dell’astrologia: dalle origini ai nostri giorni, (Mondadori, 2005).
——————————
Auguste Bouché-Leclercq – L’ASTROLOGIA NEL MONDO ROMANO (1)
Traduzione di Massimo Marra ©, tutti i diritti riservati, riproduzione vietata con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine.
Tra i precursori, partigiani o collaboratori e gli avversari dell’astrologia in Grecia, non vi è alcuna soluzione di continuità: non si saprebbero distinguere nella storia della dottrina dei periodi successivi di formazione, di lotta, di trionfo. Le teorie astrologiche restarono sempre oggetto di discussione, ed è proprio attraverso la discussione che esse sono state sollecitate ad esprimere in loro principi, a colmare le lacune ed a rimaneggiare i ragionamenti o le pratiche che porgevano il fianco alle obiezioni. Non ci si stupisce di apprendere che gli astronomi, coloro che erano più in grado di apprezzare i fondamenti scientifici dei dogmi caldei, abbiano mantenuto un atteggiamento di ostilità nei confronti di concorrenti che pretendevano di ridurre l’astronomia al ruolo di serva dell’astrologia, pretendendo peraltro di confinarla in un laboratorio in cui i numeri e le figure fornite dall’osservazione si trasformavano in oracoli infallibili e decreti del destino. Cicerone cita Eudosso, Anchialo, Cassandra e Scylax d’Alicarnasso, tra coloro che disprezzavano le predizioni astrologiche (2). Ipparco, al dire di Plinio, Credeva fermamente alla «parentela degli astri con l’uomo», e che le nostre anime «sono una parte del cielo» (3); ma questa fede, che poteva portarlo probabilmente a scambiare il suo catalogo di stelle fisse per una lista di anime divinizzate, l’allontanava abbastanza dall’astrologia considerata come mezzo di divinazione. Egli riteneva senza dubbio invalicabile la linea di demarcazione tracciata da Aristotele tra l’agitazione del mondo sublunare e la pace divina delle sfere superiori. Nelle scuole filosofiche, l’astrologia aveva incontrato, ad eccezione degli Stoici, un’accoglienza sdegnosa. Gli epicurei la scartavano con una pura e semplice eccezione di non ammissibilità; i Peripatetici avevano diviso la scienza della natura in una serie di compartimenti autonomi sottoposti alla tirannia dei numeri pitagorici, alle esigenze dell’armonia e della solidarietà universale, postulato indispensabile dell’astrologia con pretese scientifiche; la nuova Accademia, ripudiando in blocco tutto il misticismo pitagorico di cui si compiaceva la fantasia di Platone, non aveva conservato dell’eredità del maestro che il gusto dell’eristica, e crivellava di obiezioni tutte le dottrine conosciute o possibili che davano le proprie conclusioni come certe o, a maggior ragione, come infallibili. L’astrologia sarebbe stata eliminata dal mondo della filosofia e ridotta alla sola clientela delle anime semplici, d’altronde incapaci a comprenderla, se non avesse incontrato negli Stoici degli alleati e collaboratori infaticabili, rotti a tutte le finezze della dialettica, che avevano legato proprio all’astrologia la loro causa e provvedevano a mano a mano a costruire argomentazioni, risposte, distinzioni, scappatoie. Questa alleanza si era stipulata fin dalle origini, dal momento in cui Beroso importava in Grecia i dogmi caldei e Zenone fondava la scuola del Portico. Da allora, gli Stoici, dogmatici per natura ed attaccati alla loro particolare ortodossia, non vollero – né potevano – rinnegare il sistema astrologico che aveva sì gran parte nelle loro dottrine. Il solo Panezio si separa, su questo punto, dai suoi maestri e discepoli (4). Altri arretrano innanzi alla possibilità dello scisma, cercano delle transazioni. Diogene di Seleucia sul Tigri, detto “il babilonese” discepolo di Crisippo, riduceva l’astrologia al ruolo della fisiognomica, vale a dire a discernere le attitudini di ciascuno (5). Evidentemente, Diogene era stato intimidito e Panezio convinto dagli argomenti del temibile Carneade, che non aveva pari nel demolire anche i sistemi meglio costruiti. Ma Posidonio, l’uomo dal sapere enciclopedico, aveva confermato lo stoicismo sulla china delle concessioni; egli aveva rivisto tutto l’insieme delle teorie astrologiche, consolidando le parti traballanti, riempiendo le lacune e collegando le asserzioni più disparate con associazioni di idee di lunga portata, che era difficile refutare attraverso l’analisi e che sconcertavano gli avversari altrettanto se non più efficacemente di ragioni formali. È lui, probabilmente, che ha costruito o completato la fortezza astrologica attorno la quale si sono adoperati, durante i secoli, gli sforzi degli scettici, dei moralisti che invocavano il libero arbitrio, dei teologi in lotta per la loro fede. Tutti costoro erano egualmente inabili a districare il sofisma degli argomenti capziosi che essi mal conoscevano, e sospetti di ignoranza quando essi provavano, per farla finita, ad appellarsi al senso comune: Telum imbelle, sine ictu (6).
Sotto la garanzia di un sapiente assai reputato, che ebbe, in qualità di professore, la clientela dell’aristocrazia romana, la gente di mondo, fin lì diffidente o indifferente, poterono definirsi adepti dell’astrologia. Una volta scoppiata la moda, la curiosità dei dilettanti fece nascere una folla di praticanti che non volevano più aver nulla a che fare con i volgari «Caldei», gente esperta nel maneggio di cifre e figure geometriche, che reclamava una volta ancora il titolo di «matematico», titolo privo di eredi dai tempi della sparizione delle scuole pitagoriche.
L’astrologia, fino a quel momento, non aveva per alimento che le dispute filosofiche e la fede inintelligente del volgo; ella aveva infine trovato, tra questi due estremi, il terreno sul quale andare a collocarsi e prosperare: una società ricca, acculturata, latrice di quel giusto grado di scetticismo in virtù del quale le vecchie credenze che se ne vanno lasciano il posto libero alle novità che arrivano.
È la Grecia che fornisce gli astrologi: i romani, abituati da lungo tempo al ruolo di discepoli, li ammirano, li consultano e li pagano.
I
Era già da tempo che i ciarlatani, di cui non si poteva più riconoscere la nazionalità sotto il loro nome generico di «caldei», sfruttavano a Roma la credulità popolare. Non ci si sbaglierebbe affatto pensando che questi presunti caldei non fossero altro che dei greci attirati a Roma dalla moda nascente dell’ellenismo. La letteratura e l’astrologia greche erano entrate insieme, rispettivamente miranti a conquistare la prima l’aristocrazia, la seconda la plebe. I letterati non ebbero, dapprincipio, che disprezzo per i dispensatori di buona ventura, «gli astrologi da circo». Catone vietava al suo fattore di consultare i Caldei (7).
Nel 139 A. C. il pretore peregrino Cn. Cornelius Hispalus crede di dover intervenire. In virtù del suo diritto di giurisdizione sugli stranieri, egli «ordina per editto ai caldei di uscire dalla città e dall’Italia nello spazio di dieci giorni, atteso che, in nome di una fallace interpretazione degli astri, costoro gettavano, attraverso le loro menzogne, negli spiriti leggeri ed inetti, un accecamento lucroso (8)». Senza dubbio, non abbiamo qui il vero fondo del pensiero del magistrato; la preoccupazione per la borsa dei cittadini poteva benissimo essere un pretesto.
Il pericolo delle consultazioni non sorvegliate doveva apparire più nettamente a misura che la fede nell’astrologia guadagnava le classi più alte. Questa invasione, che già in precedenza abbiamo creduto di attribuire all’influenza di Posidonio, sembra essere stata abbastanza rapida. Nei tempi di rivoluzione e di peripezie improvvise che inaugura la spinta demagogica della cultura greca, non si credeva più all’equilibro provvidenziale, alla logica che lega le conseguenze agli atti volontari, ma bensì alla fortuna, caso per gli uni, predestinazione per gli altri. Quando Ottavio fu sgozzato dai sicari di Mario, si trovò su di lui, si dice, «un diagramma caldeo», prestando fede al quale egli era rimasto a Roma (9).
Ciò nonostante, gli astrologi non avevano ancora spodestato delle migliori piazze gli aruspici toscani, che, del resto, gli fecero sempre concorrenza, prendendo a prestito, all’occorrenza, dall’astrologia di che ringiovanire la loro arte. Si citano gli aruspici ufficiali di Caio Gracco, di Silla e di Giulio Cesare; non si conoscono loro astrologi familiari. Ma noi sappiamo da Cicerone che i grandi ambiziosi del suo tempo prestavano orecchio ai facitori di oroscopi. «Diverse cose – egli dice – sono state, a mia conoscenza, predette dai caldei tanto a Pompeo quanto a Crasso, quanto a Cesare stesso: che alcuno di essi non morisse se non in tarda età, se non in pace, se non con gloria! Al punto che io sono stupefatto che si trovi ancora qualcuno che creda a della gente di cui si vedono le demenziali predizioni smentite ogni giorno dalla realtà degli eventi »(10).
Qui, di stupefacente – sia detto di passata – non c’è che lo stupore di Cicerone. Gli uomini credono sempre a ciò che sperano, e la fede sfugge sempre alle smentite dell’esperienza. Se ci sono stati degli astrologi abbastanza accorti da dire a Silla che la Venere di cui egli si credeva il favorito, o a Cesare che la Venere di cui egli si credeva discendente, era il pianeta amorevole che garantiva loro lunga vita e prosperità, è assai probabile che questi spiriti forti abbiano creduto, senza ulteriori conferme, alla loro stella. Cicerone stesso, che, come filosofo, si fa beffe degli astrologi, dall’astrologia prende a prestito, come retore, delle espressioni dogmatiche. Quando egli piazza le anime dei grandi nella Via Lattea, egli non fa che sfruttare un vecchio mito platonico; ma quando chiama il pianeta Giove «fiaccola prospera e salutare al genere umano» ed il pianeta Marte «un fuoco rosso e temuto sulla terra», egli mette, nella bocca del primo africano, degli aforismi astrologici (11).
È che le idee astrologiche iniziano ad entrare nella circolazione banale, ad insinuarsi nel bagaglio intellettuale degli spiriti della cultura media. Vi entravano astronomia ed astrologia mescolate, per mezzo di una letteratura in cui i catasterismi, moltiplicati a sazietà dagli alessandrini, le descrizioni del cielo alla maniera di Arato, sembravano ai romani dei soggetti del tutto nuovi e stimolanti per le loro caparbie immaginazioni; le dottrine astrologiche penetrarono soprattutto, e per una larga parte, allorquando l’enciclopedista dell’epoca Varrone, ed il suo contemporaneo Nigidio Figulo, adepto fervente di tutte le scienze occulte, ebbero messo alla portata del grande pubblico le principali regole dell’arte dei «matematici». La cometa che apparve alla morte di Cesare dovette aiutare singolarmente la propaganda. In quanto che «prodigio» il fenomeno fu interpretato dagli aruspici; ma si può ben credere che gli astrologi non mancarono certo di dire la loro, ed è soprattutto a loro profitto che sorgeranno i gravi dibattiti sul destino di Roma, la durata probabile della sua esistenza passata e futura, il rinnovamento possibile di tutto attraverso un’ultima scadenza, forse coincidente con quella del «grande anno» astrologico, scadenza alla quale gli stoici avevano associato la propria apocatastasis o «restaurazione» dell’universo. Il successore di Cesare scelse la spiegazione più conforme alle tradizioni letterarie e la più propria a stabilire il sistema dell’apoteosi dinastica: egli «volle che la cometa fosse l’anima di suo padre (12)»; ma non gli dispiacque che gli aruspici o degli oracoli sibillini annunciassero l’avvento di un nuovo ordine di cose. Egli aveva davanti a sé l’idea che quell’astro era anche la sua stessa stella, oroscopo della nuova nascita che lo faceva figlio adottivo di Cesare. L’astrologo che gli procurava questa «gioia interiore» era probabilmente quel Teagene che era probabilmente già confidente – e che diverrà in seguito quasi il consigliere – del suo signore. È all’astrologia, in effetti, che Augusto domanda una prova sicuramente originale della legittimità del suo potere. «Egli ebbe ben presto – dice Svetonio – una tale fiducia nella sua predestinazione che divulgò il suo tema natale e coniò la moneta d’argento sotto il segno del Capricorno, sotto il quale egli era nato (13)».
Per ciò che concerne la cometa dell’anno 44, l’avvenimento sembrò dare ragione a tutti, a quelli che glorificavano Cesare e il suo figlio adottivo, come a quelli che annunciavano, nel nome delle dottrine toscane, un nuovo secolo (14) o, in nome dell’ortodossia astrologica, dei rivolgimenti e guerre sanguinose: se le epoche di crisi, nello sconcertare ogni previsione razionale, spingono al fatalismo ed alla superstizione, i romani, tra le idi del marzo 44 e la battaglia di Azio, dovettero fare dei rapidi progressi nella fede alle scienze occulte. Questa fede, l’astrologia e l’arte degli aruspici, se la disputavano con chances pressoché uguali. L’una aveva dalla sua l’antichità, l’altra la sua novità. I greci erano ingegnosi, ma i toscani erano altrettanto abili. Inferiori ai loro rivali quando si trattava di tracciare il piano di tutta una vita, gli aruspici riprendevano il vantaggio nel dettaglio dell’esistenza, soprattutto in presenza di quegli avvisi soprannaturali chiamati « prodigi», per i quali non vi era alcun posto nelle previsioni dei «matematici». Così si iniziarono a trovare dei cultori che provavano a comparare, e, forse, a combinare le due discipline. È ciò che faceva già Nigidio Figulo, e Varrone, che tutto sapeva, era uomo che tutto mescolava. L’amico suo e di Cicerone, Taruzio di Firmo, l’astrologo eminente che fece e rifece il tema di natività di Roma (15), doveva essere – il nome lo indica – un toscano la cui curiosità aveva oltrepassato le risorse dell’arte aruspicina. Vi fu a Roma contatto, rivalità, adulterazione reciproca tra la divinazione etrusca e l’astrologia, senza che con ciò si possa dire con certezza in quale misura le due discipline interagirono l’una con l’altra. Ricordiamo solamente che esse si incontravano necessariamente in domini comuni, ad esempio sull’interpretazione delle folgori ed altri fenomeni «celesti», e la localizzazione delle influenze divine o astrali nelle viscere.
Sotto il principato di Augusto l’astrologia è decisamente alla moda. Tutti si vantano di averne qualche nozione, e gli scrittori moltiplicano le allusioni, che essi sapevano colte anche dal pubblico più raffinato.
Mai gli astri hanno ricoperto un tal ruolo nella letteratura. Il catasterismo o traslazione agli astri, secondo la formula alessandrina, diviene la conclusione normale di una quantità di leggende, e la forma ordinaria dell’immortalità promessa ai grandi uomini; si ritocca la biografia degli indovini epici, dei Melampo, dei Tiresia, Dei Calcas e degli Eleno (16) per attribuirgli «la scienza degli astri», senza la quale essi apparirebbero al di sotto della loro reputazione. In fatto d’astronomia l’autore delle Georgiche è senza confronti; ma Orazio stesso mostra una sorta di civetteria nel mostrare che egli è un po’ intinto di astrologia. Non è più un fedele d’Apollo, ma un discepolo dei caldei, quello che si classifica da sé tra gli « uomini di Mercurio», colui che si felicita con Mecene d’essere sfuggito, grazie alla protezione di Giove, alla micidiale influenza di Saturno, e che, senza dubbio confuso dal disordine del calendario prima della riforma giuliana, gli domanda se egli è nato sotto la Bilancia, lo Scorpione «porzione pericolosa d’un oroscopo» o il Capricorno «tiranno del mare d’Esperia». Lui e Mecene avevano dovuto consultare qualche pratico che aveva trovato «incredibilmente concordanti» i temi natali dei due amici. Properzio non si contenta più, come Orazio, di allusioni fatte di sfuggita al tema della nuova scienza. Egli mette un scena un astrologo figlio del «Babilonese Horops» che conosce «la fortunata stella di Giove, quella del violento Marte, l’astro di Saturno che pesa su ogni capo, ciò che apportano i Pesci, il segno impetuoso del Leone ed il Capricorno bagnato dalle onde d’Esperia». Il suo matematico è di coloro capaci di «far girare i segni sulla sfera di bronzo», i «segni raddoppiati della ruota obliqua», di quelli che, per ispirare fiducia, tuonano contro la mala fede dei ciarlatani. Questo personaggio fornisce a Properzio un consulto che termina con l’avvertimento di raddoppiare «la spalla sinistra del Cancro» (17). Il poeta piacevole è forse meno astrologo di quanto non voglia averne l’aria: potrebbe essere che egli abbia preso questa minaccia da qualche gabinetto astrologico e che egli la prenda semplicemente sul serio. L’autore dell’Ibis¸esponendo il tema natale del suo nemico, parla il linguaggio degli uomini del mestiere. «Tu sei nato sfortunato – scrive – ed alcuna stella è stata propizia e leggera alla tua nascita. Venere non ha irradiato i suoi raggi in quell’ora, né Giove; né il Sole e la Luna sono stati in luoghi convenienti, e ciò che la brillante Maia ha generato dal grande Giove non ha disposto i suoi fuochi in maniera utile per te. Su di te hanno pesato l’astro di Marte, che non presagisce che a cose brutali e mai a nulla di pacifico, e quello del vecchio con la falce. Il tuo giorno natale, poiché tutto ti fu tristo, appare vile ed offuscato da una coltre di nubi» (18). Non vi sarebbe che da aggiungere delle cifre a questo brano, per farne un documento professionale.
La descrizione degli astri, di fenomeni reali o immaginari, di prodigi di questo genere interpretati, tende a divenire una vera e propria mania letteraria. Alla corte del Palatino, che dettava il tono a tutta la buona società, la scienza degli astri trovava clienti e discepoli. Germanico impiegava il suo tempo libero a tradurre in versi – come già prima di lui aveva fatto Cicerone – i Fenomeni di Arato, o anche a correggere il suo modello; ed era, senza alcun dubbio, per i più alti cenacoli che Manilio scriveva il suo Astronomicon, miscuglio singolare di fede entusiasta e di scienza dubbiosa che merita di sopravvivere come opera letteraria al discredito delle dottrine apprese frettolosamente da quest’astrologo d’occasione. Ignoriamo, del resto, se il poeta avesse appreso lì a corte il modo migliore di far la corte ad Augusto o all’erede designato, o se la penna non gli fu piuttosto tremante nelle mani per la paura di cadere sotto i colpi delle misure decretate contro i «Caldei» da Tiberio.
Si cominciava, in effetti, a capire che l’astrologia, aristocratica per essenza, sembrava fatta per risvegliare e nutrire le grandi ambizioni. Tiberio lo sapeva, si dice, per esperienza diretta, aggiunta a quella del suo padre adottivo. Si racconta, che, caduto in disgrazia ed esiliato a Rodi, egli aveva preso delle lezioni da «matematico Trasillo» e che, più tardi, egli aveva divinato in Galba l’uomo «che avrebbe un giorno assaporato l’impero (19)». Seguendo la leggenda, si finisce col credere che egli avesse creato una sorta di gabinetto nero, in cui dei banditori d’oroscopi raccoglievano i segreti dei privati e da cui, dopo l’esame del tema natale fatto da lui stesso o da Trasillo, egli colpiva a colpo sicuro le teste segnalate per il loro importante destino (20).
Si creano in genere, intorno degli oracoli, una folla di aneddoti tendenti a dimostrare la loro infallibilità e l’inanità degli sforzi degli uomini – per quanto prevenuti – per sfuggire al destino prefigurato; così l’astrologia stessa, il cui credito era ormai acquisito, è creduta mostrare in anticipo ai personaggi storici le tappe della loro esistenza. Ed è una gioia per i credenti vedere le previsioni realizzarsi a dispetto dei dubbi, delle precauzioni o in maniera completamente diversa da ciò che si era supposto.
Così avvenne, ad esempio, nel racconto di Tacito: avendo Tiberio lasciato Roma nel 26, «gli esperti di cose celesti assicurarono che Tiberio era uscito di Roma sotto dei movimenti d’astri tali che il ritorno gli era impossibile. Questo fu la perdizione di una folla di persone che credettero alla sua morte prossima e ne sparsero la voce; essi non prevedevano, in effetti, tanto il caso pareva incredibile, che per undici anni l’imperatore si sarebbe esiliato volontariamente dalla sua patria. Si vede come l’arte confina dappresso con l’errore e come la verità si avviluppi d’oscurità. L’annuncio che egli non sarebbe rientrato in città non era che una parola nell’aria; il resto, coloro che agirono in questo modo, lo ignoravano»(21).
I consulti astrologici invasero la storia tramandata dai compilatori di curiosità e dagli psicologi che dissertano sulle voci di corridoio. Si tratta di Caligola, a cui il matematico Sulla «predice che la sua morte era certamente vicina»; si tratta di Nerone, a cui «dei matematici avevano predetto che sarebbe un giorno stato destituito» o a proposito del quale dei Caldei avevano risposto a sua madre Agrippina che «avrebbe conquistato l’impero ed ucciso sua madre». È il Nerone che attende, per proclamarsi imperatore, «il momento favorevole indicato dai caldei» o che allontana le minacce d’una cometa con delle esecuzioni ordinate come equivalenti di sacrifici umani, su consiglio dell’astrologo Balbillus. Tacito sa che «il salotto di Poppea aveva ospitato quantità di matematici, mobilia detestabile per una casa di principessa». È lì, forse, che uno dei frequentatori della casa, Otone, aveva incontrato l’astrologo Tolomeo, che lo accompagnerà a Roma e lo spingerà a ribellarsi contro Galba. Poi seguono i Flavi, tutti e tre seguiti dai loro astrologi, che non tolleravano che questi a Roma: Vespasiano, al seguito del quale ritroviamo il consigliere di Nerone, Balbillus; Tito, che era abbastanza colto per studiare lui stesso il tema natale dei due ambiziosi, ed abbastanza generoso per perdonarli ed avvertirli anche «di un pericolo che sarebbe giunto loro in seguito, e da parte di un altro»; Domiziano, che, come d’altronde Tiberio, «esaminava i giorni e le ore delle natività dei primi cittadini» e nel contempo colpiva, dal momento che egli mise a morte Mezio Pomposiano che già sotto Vespasiano passava per avere «una nascita imperiale» e risparmiò Nerva, poiché un astrologo gli aveva garantito che il vegliardo non aveva più che pochi giorni da vivere. Egli non sapeva che Nerva non aveva affatto bisogno di vivere a lungo per succedergli. Un uomo che cerca di uccidere i suoi successori è sempre ridicolo, e la storia qui si diverte a spese di Domiziano. Si racconta ancora che, avendo fatto arrestare «il matematico Ascletarione», colpevole senza dubbio di aver predetto al morte prossima del tiranno, egli volle ad ogni costo dimostrare la sua impostura, e che invece la prova tornò a suo danno. «Egli domandò ad Ascletarione quale sarebbe stata la sua stessa fine; quando questi gli assicurò che egli sarebbe stato di lì a poco sbranato dai cani, egli ordinò di metterlo a morte senza indugio, e, per dimostrare la frivolezza dell’arte dell’indovino, di seppellire il cadavere con ogni cura. Ma, nell’esecuzione dei suoi ordini, un improvviso uragano, rovesciò la pira funebre, ed i cani dilaniarono il cadavere per metà carbonizzato». A dire di Svetonio egli conosceva da molto tempo l’anno, il giorno e l’ora della sua morte. «Era ancora giovane quando dei caldei gli avevano predetto tutto ciò, tanto che un giorno, a tavola, poiché egli non toccava affatto i funghi, suo padre si era preso gioco di lui apertamente dicendo che invero conosceva assai male il suo destino, se non temeva, piuttosto, il ferro.». In effetti, la vigilia della sua morte, egli fa mostra della sua competenza astrologica annunciando che «l’indomani la luna si sarebbe coperta di sangue nell’acquario, e che si sarebbe verificato un avvenimento di cui gli uomini avrebbero parlato in tutto l’universo.».
La lista dei consulti imperiali non è certo chiusa qui, con le biografie di Svetonio. Come lui, i suoi continuatori, gli scrittori della Storia Augustea, hanno cura di temperare con racconti di ogni sorta la noia che esala dalla loro prosa semibarbara, e l’astrologia non è dimenticata. Ecco Adriano, che, curioso di tutto ed ancor più preoccupato di sé, non poteva mancare di apprendere l’astrologia per suo proprio uso. «Egli immaginava di conoscere l’astrologia al punto che, alle calende di Gennaio, metteva per iscritto tutto ciò che sarebbe potuto accadergli nel corso dell’anno; così, l’anno della sua morte, egli aveva descritto tutto ciò che avrebbe fatto fino all’ora stessa del suo trapasso.». Il cronista riprende questo dettaglio da Mario Massimo, uno scrittore che, in base a questo saggio, non possiamo che collocare nella categoria dei mistificatori. Se come si dice, Adriano ammetteva degli astrologi nella cerchia dei sapienti, letterati ed artisti di cui si circondava, ciò era senza dubbio col pretesto di mettersi alle prese con Favorino, il più sottile sofista dell’epoca, che esercitava volentieri la sua verve mordace sui dogmi astrologici. Ci si parla ancora di Marco Aurelio che consultava i Caldei sui segreti d’alcova di Faustina, e decise, sulla base del consiglio di questi ultimi, di far bagnare Faustina nel sangue del gladiatore che fu il padre di Commodo. È il momento in cui comincia la confusione tra astrologi e maghi. Poi, abbiamo Settimio Severo che, al tempo in cui non era ancora che legato lugdunense, «studiava i temi natali delle ragazze da marito, essendo lui stesso assai esperto nell’arte dell’astrologia. Avendo appreso che ve ne era una in Siria il cui tema natale provava che sarebbe stata sposa di un re, egli la domandò in sposa – era Giulia – e l’ottenne per l’intermediazione di qualche amico». Come si vede, l’astrologia, scienza universale, perfezionava l’arte di arrivare ai propri fini per mezzo delle donne. Essa, per un uomo che conosceva in anticipo il termine del suo destino, facilitava così in modo singolare l’arte di sorpassare i propri rivali. Severo, conosceva abbastanza bene il suo proprio destino da sapere, all’atto della sua partenza per la Bretagna, che non sarebbe più ritornato indietro, e tale sicurezza doveva venirgli soprattutto dal suo tema natale, che egli aveva fatto appendere alla volta del suo pretorio.
Si ripetono per Caracalla i racconti fatti sul conto di Tiberio, le uccisioni ordinate a partire dai «diagrammi di posizioni siderali».
Anche Alessandro Severo è un adepto dell’astrologia, per la quale egli fonda, a quanto si dice, delle cattedre di insegnamento retribuite dallo stato, con borse di studio per gli studenti. La storia aneddotica fa di lui un pedante, e gli si attribuisce un po’ dell’attitudine dell’astrologo che, con gli occhi fissi al cielo, piomba inopinatamente in un pozzo. «Il matematico Trasibulo, suo amico intimo, gli aveva detto che egli sarebbe necessariamente perito per la spada dei barbari, ed egli fu subito incantato da questa prospettiva, poiché egli si attendeva una morte da guerriero e degna di un imperatore; poi egli si mise a dissertare, mostrando che tutti gli uomini eminenti erano morti di una morte violenta, citando Alessandro, di cui egli portava il nome, Pompeo, Cesare, Demostene, Cicerone ed altri insigni personaggi che non erano finiti pacificamente. Egli si esaltò al punto da giudicarsi comparabile agli dei, dovendo morire in guerra. Ma l’avverarsi della profezia sarà ingannevole, perché egli morrà per una spada barbara, ma maneggiata da un commediante barbaro, ed in tempo di guerra, ma non in combattimento».
I due primi Gordiani non ebbero il tempo di regnare, ma conoscevano, pare, il loro destino. «Gordiano il vecchio consultò un giorno un matematico sul tema natale di suo figlio. Questi, gli fu risposto, sarebbe stato figlio e padre di imperatore ed imperatore lui stesso. Poiché Gordiano il vecchio rideva, si dice che il matematico gli mostrasse il posizionamento degli astri, e, citando passaggi di vecchi libri per provare di aver detto la verità, predisse pure, al vecchio ed al giovane, il giorno ed il genere della loro morte, ed anche il luogo. E ciò, con la più ferma convinzione di essere nel vero».
Possiamo ora eliminare dalla storia queste ulteriori ripetizioni, questa aneddotica sospetta, parole forgiate spesso dopo gli avvenimenti, e conservarne l’essenziale, vale a dire l’opinione e i pericoli che poteva offrire un metodo divinatorio reputato infallibile dal punto di vista della sicurezza dei potenti. L’esattezza materiale dei fatti contenuti nelle predizioni qui è questione di secondo piano: ciò che conta come fatto sicuramente reale e della più grande importanza, è l’idea che se ne ha, ovvero precisamente quella che si fissa nelle leggende e che tende a tradursi in atti reali per imitazione. Non fu certo per semplice capriccio di tiranno che Tiberio mise la sua polizia alle calcagna dei caldei. Già un mezzo secolo prima, al tempo in cui l’imminenza del conflitto previsto tra Antonio ed Ottavio sovreccitava le immaginazioni, Agrippa aveva «cacciato dalla città gli astrologi e i maghi». Alla fine del suo regno, Augusto aveva interdetto ad ogni sorta di indovini le consultazioni a porte chiuse e, nel caso di previsioni concernenti la morte, anche quelle a porte aperte. La misura era saggia, tanto utile alle famiglie quanto al potere, ma inapplicabile. È a seguito del processo di Druso Libo (16 D. C.) che Tiberio si decide ad inasprire le pene. Libo era un giovane sciocco di cui gli indovini – I caldei come gli interpreti di sogni ed i negromanti – avevano sfruttato l’ambizione. «Delle riunioni del senato furono fatte per cacciare d’Italia i matematici e i maghi: uno di essi Lucio Pituanio, fu precipitato da un a rupe; quanto a Lucio Marcio, i consoli lo condussero fuori dalla porta Esquilina, e là, dopo aver fatto squillare le trombe, gli inflissero il supplizio al modo antico».
Gli astrologi apprenderanno a nascondersi un po’ meglio. Quattro anni più tardi, il processo di Lepida rivela che questa gran dama, adultera ed avvelenatrice, aveva anche «consultato dei caldei sulla famiglia di Cesare».
Sotto il regno di Claudio, nuovi scandali. Lollia, che aveva disputato ad Agrippina la mano di Claudio, è, ad istigazione di quest’ultimo, accusata di aver consultato «i caldei, i maghi ed aver posto quesiti ad una statua di Apollo Clario «sul matrimonio dell’imperatore». Scriboniano fu esiliato con l’accusa banale «di aver cercato di sapere per mezzo dei caldei, la fine dell’esistenza del principe». Anche in questo caso si decise una volta ancora di cacciare d’Italia i matematici, ed a questo fine fu riunito un «consiglio del Senato rigoroso ed inutile».
Perseguitati, gli astrologi divennero ben presto personaggi di pubblico interesse, ed anche se espulsi dall’Italia, si poteva consultarli per corrispondenza. Tacito ci parla di uno di questi esiliati, Pammene, «rinomato nell’arte dei caldei e per questa ragione coinvolto in una folla di relazioni», che riceveva dei messaggi e reinviava a Roma i suoi pronostici ad Anteo ed Ostorio Scapula, i quali furono denunciati a Nerone come cospiratori e «scrutatori del destino di Cesare». I matematici mostreranno dello spirito – o, semplicemente, lo si attribuirà loro – quando Vitellio, per punirli dell’incoraggiamento da loro prestato ad Otone, «pubblica un editto che ordina loro di uscire dalla città e dall’Italia prima delle calende di ottobre. Ben presto circolò un libello in cui si pubblicizzava il divieto per Vitellio Germanico, imposto dai caldei, di essere ovunque egli fosse nel medesimo termine delle calende». I derisori ebbero di che dividersi, dal momento che Vitellio sopravvisse di soli tre mesi alla scadenza indicata.
Le espulsioni riprenderanno sotto Vespasiano, il quale, pur avendo presso di sé i suoi astrologi, non intendeva lasciare che altri sfruttassero il pubblico; riprenderanno inoltre sotto Domiziano, che diede agli astrologi l’onore dell’espulsione da Roma nello stesso tempo ed allo stesso titolo dei filosofi.
È fin troppo ovvio che tutto questo chiasso a vuoto, queste molestie intermittenti e debolmente spinte, lontano dal discreditare l’astrologia, accrebbero il suo prestigio ed allargarono la sua portata all’interno della considerazione del pubblico. Delle dottrine che preoccupavano in questo modo i governanti, non potevano più passare per dei semplici giochi dell’immaginazione. È così che le donne più frivole, le più incapaci a comprendere gli stessi rudimenti elementari dell’astrologia, si invaghirono della grande arte invisa alla polizia imperiale. Esse non rinunciano alle loro altre superstizioni, dice Giovenale, «ma è nei caldei che esse hanno maggior fiducia. Tutto ciò che dirà l’astrologo, passerà ai loro occhi come proveniente direttamente dalla bocca d’Ammone, dal momento che a Delfi gli oracoli tacciono e che la specie umana è condannata ad ignorare l’avvenire. Ma colui che primeggia sugli altri astrologi è quello che è stato più volte esiliato, la cui amistà ed il grimorio grassamente pagato causarono la morte del temuto e rispettato Otone. Si ha fiducia nella sua arte se la sua mano destra e la sua sinistra fanno tintinnare catene di ferro, se egli soggiorna lungamente in qualche prigione militare. Nessun matematico può aver successo se non è mai stato condannato; solo quello che ha rischiato di morire, che a gran pena ha avuto una possibilità di essere esiliato in una Ciclade, e che è infine rientrato dalla piccola Seriphos. Ecco l’uomo che la tua Tanaquilla consulta sulla morte troppo lenta della mare, affetta da itterizia, e sul suo futuro. Quando seppellirà sua sorella ed i suoi zii? Il suo amante gli sopravvivrà? È il più gran favore che possano accordargli gli dei. Ella vuol sapere ciò che apporta la lugubre stella di Saturno, in quale posizione Venere si mostra favorevole, quali mesi sono votati alle perdite e quali ai guadagni. Ma stai bene attento ad evitare colei che tu vedi maneggiare delle effemeridi che han preso, nelle sue mani, il lucido grasso dell’ambra; questa non consulta più, è consultata. Che suo marito parta per la guerra o per il suo paese, ella non andrà con lui se i calcoli di Trasillo glielo sconsigliano. Che a lui prenda voglia di farsi scarrozzare non fosse che ad un miglio da Roma, lei domanda l’ora al suo libro; se l’angolo dell’occhio, troppo stropicciato, gli pizzica, ella ispeziona il suo tema natale, prima di cercare un collirio. Ed anche se fosse malata ed a letto, ella non prenderà nutrimento che ad una certa ora propizia, quella che gli avrà indicato Petosiris».
Giovenale è aduso all’iperbole, ma gli si può credere quando egli non fa che vantare le attrattive del frutto proibito. L’attacco e la celia sono un indice di popolarità: è la “reclame” dell’epoca. Si incontra, negli epigrammi di Lucillo, un contemporaneo di Nerone che ama celiare sul conto degli astrologi, qualche tratto genuino di buona commedia. Ad esempio, il personaggio dell’astrologo Aulo che, prevedendo di non avere più che quattro ore di vita, alla quinta si impicca per rispetto a Petosiris.
Questo Petosiris che diviene così l’oracolo degli adepti dell’astrologia, passava per essere stato, ai suoi tempi � almeno sette secoli prima della nostra epoca – un sacerdote egiziano collaboratore di un non meno favoloso re e profeta Nechepso. Il libro, un grosso libro che circolava sezionato in estratti, sotto forma di effemeridi o almanacchi, si diceva proveniente da archivi ieratici egiziani. In realtà doveva essere stato composto ad Alessandria, come tanti altri apocrifi, da falsari che volevano approfittare della moda sempre più diffusa dei culti e delle tradizioni provenienti dalle rive del Nilo, per confiscare, a favore dell’Egitto, la fama di una scienza fin lì identificata come caldea. Che il libro sia stato composto verso il periodo di Silla o piuttosto un secolo più tardi, comunque è a partire dai suoi scritti che l’astrologia, considerata come eredità delle due più antiche civiltà orientali, ebbe una ulteriore garanzia di affidabilità, arricchendosi, peraltro, di una nuova branca, la iatromatematica, ovvero l’astrologia applicata alla medicina. Ogni dottrina, scienza o religione che può convertirsi in arte medica, si vota al successo attraverso la via più breve. Appena conosciute, le ricette del «Re Nechepso» procurarono una bella fortuna al medico Crenas di Marsiglia, che «regolando l’alimentazione dei suoi clienti sui movimenti degli astri, grazie ad una effemeride matematica, ed osservandone le ore, lascia alla fine dieci milioni di sesterzi, dopo aver speso altrettanto per la costruzione di fortificazioni per la sua città natale e per altre costruzioni».
Plinio, che non ama né i medici né gli astrologi, attesta, deplorandola, l’infatuazione dei suoi contemporanei per l’astrologia, divenuta la religione di coloro che non ne hanno altra. Da un capo del mondo all’altro – egli dice – si invoca ad ogni momento la Fortuna. «Ma una parte dell’umanità dileggia anche questa, ed affida il proprio avvenire agli astri che presiedono alla nascita, pensando che la divinità abbia deciso una volta per tutte il destino di tutti gli uomini alla nascita, cessando, dopo, di occuparsi del resto. Questa idea ha cominciato ad affermarsi, e la folla, sia degli istruiti che dei senza cultura, si precipita ai consulti». L’astrologia coinvolge tutti. In questa mandria che si precipita dal lato dove la spinge il gusto del giorno, vi sono coloro che la considerano una scienza naturale, ed altri che la prendono per una religione, altri che la considerano un perfezionamento della vecchia magia, e tutti sono lusingati, in fondo, di praticare da vicino gli astri ed avere la loro stella in cielo. I più semplici credono, alla lettera, che ciascuno è rappresentato in cielo da una stella di splendore proporzionale alla propria condizione, stella che nasce con l’individuo e cade dalla volta celeste alla morte di questo. Quelli che avevano una idea sommaria del cammino degli astri e dei momenti propizi che nascono in tali movimenti, trovarono adeguate conferme in effemeridi adattate ad ogni specie d’uso. Infine, gli uomini colti, quelli che volevano riportare tutto a dei principi razionali, ebbero completa soddisfazione allorquando, nel mezzo del secolo degli Antonini, il più grande astronomo dell’epoca, Claudio Tolomeo d’Alessandria, fece entrare la scienza astrologica, opportunamente ordinata ed epurata da lui stesso, in un corpo di dottrine scientifiche in cui le prove sperimentali si raggruppavano in teorie improntate alle più ingegnose speculazioni dei filosofi pitagorici, peripatetici e stoici.
In questo invasamento generale, i giureconsulti applicarono o lasciarono sonnecchiare, a seconda dei casi, le leggi repressive. Dalla pubblicazione del Tetrabiblos di Tolomeo, gli era stato difficile sostenere – come fa ancora Ulpiano per abitudine professionale – che tutti i «matematici e Caldei» erano degli impostori che sfruttavano imbecilli. Ma una scienza può avere solide basi e nondimeno essere pericolosa. Era proprio perché si prestava fede ai calcoli astrologici che si era così dubbiosi sulla legittimità dell’astrologia. Così, in materia di divinazione, la giurisprudenza esitava. All’inizio si era pensato che non si poteva punire la scienza, ma solo l’esercizio del mestiere. Poi, con degli accessi di indulgenza, si era considerato come contravvenente sia l’indovino che il suo cliente, e si erano graduate le pene a seconda dell’importanza della consultazione. La pena capitale era comminata solo a coloro che consultavano «sulla salute del principe». Sotto il regno di Commodo, Settimio Severo aveva finito per esser condannato per un crimine di questo genere. In fondo, ciò che impediva ai legislatori di classificare l’astrologia tra le scienze inoffensive o perfino utili, a dispetto delle proteste dei suoi dottori, era che il pubblico si ostinava a confonderla con la magia, scienza considerata di essenza antisociale, essendo l’arte di sospendere e violare tutte le leggi, divine, umane e naturali. «Caldei» e «Magi» erano stati sinonimi sin dalle origini, e gli «Egiziani» con le loro farmacopee e chimiche magiche, meritavano meglio ancora la reputazione di stregoni. Dopo la caduta di Alessandria (296), dove libri e professori di scienze occulte pullulavano, Diocleziano emise un editto che sarà, nella sostanza, conservato anche dai giureconsulti di Giustiniano: «È interesse pubblico che si apprenda ed eserciti l’arte della geometria. Ma l’arte matematica è condannabile, ed è assolutamente interdetta». I sovrani del basso impero rinnovarono, di tanto in tanto, gli editti che colpivano indistintamente tutti gli indovini: i mathematici naturalmente figurano nel numero, e la parola accompagna o sostituisce l’appellativo di «Caldei», ovvero maghi. Talvolta, l’astrologia è presa di mira da sola, come nell’editto del 409, emesso a Ravenna, che ordinava di bruciare «sotto gli occhi dei vescovi» i libri dei matematici e che espelleva «non solo da Roma, ma da tutte le città, coloro tra gli indovini che non si convertivano alla religione cattolica.
Non è tanto lo zelo religioso che qui manifesta Onorio la forza motrice che, ordinariamente, mette in movimento la cancelleria imperiale: è piuttosto la paura delle previsioni ad uso degli ambiziosi e dei sortilegi alla famiglia regnante. Gli astrologi, dal canto loro, avevano escogitato un mezzo sicuro di calmare le inquietudini delle autorità. Essi insegnavano che l’imperatore, vicario di Dio sulla terra, non era sottomesso ai decreti degli astri, che sono divinità di levatura minore. L’onesto Firmico, che dedica il suo trattato d’astrologia ad un funzionario imperiale, arrivato sotto Costantino e Costanzo alle più alte dignità, fa del suo meglio per accreditare questa dottrina: «Voi darete i vostri responsi in pubblico – dice al suo lettore – ed avrete cura di prevenire quelli che verranno a consultarvi che voi pronuncerete ad alta voce tutto quel che avete da dire sulle loro richieste, affinché non vi si pongano di quelle domande che non si ha il diritto di fare ed alle quali non è consentito rispondere. Fate attenzione a non dir nulla, nel caso ve ne domandino notizia, sulla situazione dello stato e la vita dell’Imperatore, poiché non bisogna e non si deve parlare, mossi da colpevole curiosità, dello stato della repubblica. Colui che rispondesse a domande sul destino dell’imperatore, sarebbe uno scellerato, degno di ogni castigo, atteso che, su tale soggetto, voi non potete né dir nulla, né trovare qualcosa da dire. È cosa buona, in effetti, che voi sappiate che tutte le volte che gli aruspici sono consultati per dei particolari sullo stato dell’imperatore, e che vogliono rispondere alle domande, le viscere destinate a quest’uso e le posizioni delle vene li gettano in un inestricabile confusione. Ugualmente mai un matematico ha potuto affermare nulla di vero sul destino dell’imperatore, perché l’imperatore, unico, non è sottomesso al movimento delle stelle, ed è anzi il solo sul cui destino le stelle non hanno il potere di pronunciarsi. In effetti, dal momento che egli è il maestro dell’intero universo, il suo destino è regolato dalla volontà del Dio supremo, e, essendo sottomessa alla potenza dell’imperatore l’intera superficie del mondo, egli stesso è classificato tra quelle divinità cui la divinità principale ha affidato il compito di fare e conservare tutte le cose. È questa la ragione maggiore della confusione degli aruspici: in effetti, qualunque sia l’essere sovrannaturale da essi invocato, questo, essendo di potenza minore, non potrà mai svelare il fondo di quella potenza superiore che risiede nell’imperatore».
Il ragionamento è assai sottile, da classificare senza dubbio nella categoria della malizia più evidente. Firmico l’aveva probabilmente preso a prestito dagli gnostici, che dicevano i cristiani emancipati, per mezzo del battesimo, dalla dominazione degli astri. Oppure dai teologi, che affermavano l’indipendenza del Cristo dai dettami astrologici. Il difficile era di fare accettare, e, soprattutto, di credere in prima persona ad una simile costruzione intellettuale. Firmico, ha tutta l’aria di dimenticare che, nella prefazione del suo libro, egli ha passato in rivista una quantità di grandi uomini, e mostrato dei maestri del mondo come Silla e Cesare, descrivendo tutti costoro come guidati dagli astri. Dopo di ciò, egli indirizza una accorata orazione al Sole, alla Luna e ai cinque pianeti, per pregarli di conservare perpetuamente l’impero a Costantino ed alla sua posterità. Se gli astri non hanno alcun potere sull’imperatore, perché domandar loro ciò che non possono né dare né togliere?
Evidentemente, queste finezze da azzeccagarbugli non ingannavano, nessuno, e coloro che facevano finta di prenderle sul serio, avevano senza dubbio interesse ad affettare ingenuità. Allora come prima, i libri astrologici, almeno quelli che continuavano a circolare ben nascosti dai mantelli, continuavano ad occuparsi con predilezione dei sovrani e di previsioni utilizzabili in politica. Il buon senso voleva che il destino dei re fosse, a preferenza di quello dei ciabattini, descritto nelle stelle, e la grande arte avrebbe perduto il suo prestigio ad interdirsi ogni rischioso pronostico sul destino dei grandi. Non potendo, né volendo rinunciare alla loro onniscienza, gli astrologi preferirono circondarsi d’ombra e di mistero; essi facevano prestare ai loro discepoli il giuramento di non rivelare nulla ai profani dei segreti della loro scienza; essi affettavano di assimilare il loro insegnamento una iniziazione religiosa o alle dottrine esoteriche di Pitagora e di Platone. Vi era, in questi atteggiamenti, tanto di prudenza che di civetteria.
Nel IV secolo, l’astrologia non può più essere sorvegliata, tanto è capillarmente diffusa. Essa si infiltra in tutti i metodi divinatori, e molti sono persuasi che anche gli dei ispiratori degli oracoli non conoscono l’avvenire che per mezzo degli astri. Di tanto in tanto, qualche scandalo avverte che gli astrologi non sanno sempre prevenire la caduta dei loro protettori. Quando Parnasio, il prefetto d’Egitto, cadde in disgrazia sotto Costanzo, ciò avvenne probabilmente per aver consultato un astrologo, «su cose che la legge non permette di apprendere». Giuliano non ebbe bisogno di oroscopi per apprendere l’ora della morte di Costanzo, se era in grado di interpretare da solo ciò che un fantasma notturno ebbe la compiacenza di dirgli, ovvero che Costanzo sarebbe morto quando Giove fosse entrato nell’Acquario e Saturno nel 25° grado della Vergine.
Nel celebre processo del 371 figura un astrologo, Eliodoro, ma pressoché unicamente come delatore: la «consultazione sul prossimo imperatore» che esaspera tanto Valente, proveniva da una tavola e da un anello magici. Siamo mal informati sui dettagli delle rivolte di palazzo tra Teodosio e Giustiniano, ma l’astrologo Palchos ci comunica che nel 483, l’usurpatore Leonzio aveva scelto il suo momento dopo la consultazione di due «matematici», e c’è ragione di credere che gli astrologi continuassero ad avere gli occhi fissi come un tempo sulle stelle degli ambiziosi.
Insomma, l’astrologia, che mai potrebbe avere presa diretta sulle classi popolari, ebbe nel mondo greco-romano tutta la fortuna che poteva avere, e la persecuzione più virtuale che reale che subì non le nocque affatto. Se si volesse misurare il cammino percorso dai tempi di Giovenale fino a quelli di Ammiano Marcellino, per quel che concerne la popolazione di Roma, ovvero della città che più aveva perseguitato gli astrologi, è sufficiente raffrontare le testimonianze di questi due autori tenendo presente l’esagerazione del primo e l’animosità del secondo. Ammiano Marcellino, venuto a Roma verso il 380, è scandalizzato dai vizi dell’aristocrazia romana molle, adusa al gioco, inaridita, incredula e superstiziosa. «Molti di loro negano che vi siano potenze superiori nel cielo; tuttavia essi non si mostrano in pubblico, non mangiano né si bagnano senza avere prima consultato attentamente le effemeridi, per sapere, ad esempio, dove si trova il segno di Mercurio o quale parte del Cancro occupa la Luna nella sua corsa celeste.». A dire del nostro severo provinciale, gli uomini dei suoi tempi sono giusto al punto in cui erano le donne dei tempi di Giovenale. Una certa fede nell’astrologia fa parte del senso comune, ed è solo l’eccesso che passa per superstizione.
NOTE:
(1) Questo articolo forma il capitolo XVI ed ultimo di un’opera destinata ad apparire prossimamente, L’Astrologie grecque. L’autore ha qui soppresso, riservandole per il libro, le abbondanti note che chiariscono e commentano il testo, limitando all’indispensabile i riferimenti.
(2) Cicerone, De Divinatione, II, 42
(3) Plinio, Historia Naturalis, II, par. 95
(4) Cicerone, De Divinatione, II, 42
(5) Cicerone, De Divinatione II, 43. Il suo compatriota e contemporaneo, il “caldeo” Seleuco, astronomo, fisico e geografo, aveva rotto del tutto con l’astrologia. Crf. S. Ruge, Der Chaldäer Seleukos, Dresden 1865.
(6) Su Posidonio come fonte principale del Tetrabiblos di Tolomeo vedi il magistrale studio di Fr. Boll, Studien über Claudius Ptolemäus (Jahrbb. f. kl. Philol. Supplbd. XXI (1894), p. 49-244.
(7) Cicerone, De Divin. I, 58. Cato, De Agriculi, I, 5, 4.
(8) Val. Maxim., Epit. I, 3, 3.
(9) Plut., Marius, 42
(10) Cic. De Divin., II, 47
(11) Cic., Rep., VI, 17
(12) Serv. ad Virg., Ecl., IX, 47, Aen, VIII, 681
(13) Plin. Hist. Nat., 2, §. 4
(14) Cfr. la mia Histoire de la divination, IV, p. 91 e sgg., e l’articolo Haruspices nel Dictionnaire des Antiquités di Darembourg e Saglio.
(15) Cic. De divinatione, II, 47.
(16) Cfr. Virg. Aen III, 360; Stat. Theb., III 558 etc.; Properzio (V, I, 109) disdegna Calcas, che non conosceva l’astrologia.
(17) Properzio V, 1, 75-108.
(18) Ovidio, Ibis, 207-216.
(19) Tac. Ann.VI, 21. Dio. Cass. LVI, 11. LVII, 19. Cf. Svet. Tiber. 14
(20) Dio. Cass. LVII, 19
(21) Tac. Ann.IV, 58.